* * * * * * *
La fertile sofferenza è la pena feconda del vivere, il patimento che si trasfigura e si sublima in ricchezza spirituale e nobile forma d’arte, in una metamorfosi che conforta e redime, sprigionando tesori da annunciare e da dispensare, perché siano a loro volta fecondi. Sofferenza come sfumata condizione originata dal dolore, ora più, ora meno intenso, al variare delle esperienze e degli affetti coinvolti, nel segno di un costante senso drammatico, ma non rovinoso, della vita e della fragile pochezza / della qualità umana.
Sofferenza dell’intima richiesta, inappagata, di terra natia, nei versi “d’annata”, nel nexŭs che stringe al luogo adottivo, ambiguo paese / di molti paesi, dove l’anima si sente abbracciata e distante, accolta come una tessera mancante, e tuttavia non conforme ad un codice in cui non si riconosce, cellula / che non risponde / mansueta… Luogo dove stagioni, squarci naturali, colori e aromi di piante, eventi festosi non leniscono la tormentata esperienza dello spirito, anche per l’inclinazione dello spirito stesso: perciò la notte di sagra dall’innocente / odore di vendemmia pure festeggia i tuoi cani / che mi hanno raggiunto ai fianchi; l’ibisco già stasera… cadrà vinto dall’innegabile stagione; il basilico mai aveva avuto / tanto profumo / come mentre moriva, e l’estrema furia di febbraio / rotola nella spietata / pancia del vento. Perciò gli artifici persiani / in un caleidoscopio sono amarezza di vedere in penombra con occhio ferito; perciò nella feroce memoria riaffiorano ritagli drammatici: l’esule solo e il suo cumulo deserto, le vite promesse alla morte, la schiena opposta / come un no definitivo a un desiderio d’amore, notti non abitate e desolati mattini… Perfino la poesia si ritrae quando sembra prendere il sopravvento l’istanza di un vivere concreto, per cui mi è urgente la vita / per liberarmi dalle spire / della sola teoria.
…………..Una siffatta visione dell’esistere trova comunque lirica espressione, ma l’indole non può indulgere alla sentimentalità languida e meglio si dispiega in un alveo di moti affettivi che, per essere forti e misurati, sono tanto più credibili e ricchi.
Sofferenza del passato che nel ricordo si fa rimpianto, più spesso amarezza per destini impietosi, un passato che ha nomi femminili ed un toponimo.
…………..Albertina… una valigia sulla quale siedi /davanti alla tua casa vuota / gli occhi glauchi ormai opachi e la faccia di cera;
…………..Linda… bionda e bellissima… che il decadimento degli anni aliena ed offende nella tua casa chiamata Cieli Azzurri;
…………..Luisella… che attraversa una sorte quasi persecutrice (come tutti i buoni non aveste fortuna), ma che l’amore sorregge ancora;
…………..Elena… il cui canto giungeva dall’altra parte di un muro violato da una crepa, madre che perse il suo primo fiore “perfetto”, falciato da un bolide impazzito, e che il tempo ha inasprito;
…………..Eva… prosperosa ed inquieta, e sventurata, dalla vita turbolenta e scriteriata, donna di tutti “per oblio”, che in un giorno dei pochi che eri sola / cadesti sotto un maglio senza scampo;
…………..Calle De Lena, lo spazio dei tempi più lontani … “il mondo che era al di fuori” di una nobile villa,
…….e sempre lo sarà da ville antiche
…….in fondo a strade che mimano la vita
…….balenando un miraggio di salita
Sofferenza, e lacerante, di un distacco, di una perdita grave e irreparabile che spinge al tentativo di recupero e di chiarimento attraverso la scrittura: non un dire per dire che piange sterile e puerile la disperazione del non avere più, dell’illusione disattesa, un “qui per terra / mi getto, e grido e fremo” senza orizzonte e senza luce, ma una parola che fruga e rimodella per non smarrire, e raccoglie tutte le perle di una realtà che si è sgranata, di una collana rotta rotolata in frammenti, ricomposta rigo dopo rigo per rimetterla al collo, dove insista sul cuore, lo stesso che un tempo saliva nelle mani e nel viso ed ora si avvince attraverso la poesia. L’indicibile diventa suono, che se non restituisce la carne, riporta e tende quanto della carne divenne anima, la sostanza più vera di ogni più vero sentimento.
…………..I silenzi lunghi e impenetrabili del rapporto in vita, si fanno, in memoria, voce inesauribile e pervia, e perfino la pietra sul cuore, impossibile a rimuoversi, pare scivolare per incanto, attraverso l’appartenenza di un immenso taciuto che si risolve, ora, in un immenso dichiarato, per quanto l’amore continui ad essere infilato tra labbra serrate.
…………..Dallo straziante sapevo che morivi, dal desiderio profondissimo che magari vivesse ancora quell’affetto che / non dimostravi mai, dal ricordo lancinante di camminate lente / allacciati ai fianchi / per lugubri corridoi, i due vecchi che si amano si amano ancora, dentro versi che sono mirabilmente ben più che lemmi accostati, ben più che parole accordate, la sinfonia di un amore grande, dove gli strumenti gridano e si placano, infine e finalmente, quando i tuoi occhi risposero / a tutte le domande.
…………..Vero che improvvisamente tutto fu immobile, ma, altrettanto, che l’immortalità creduta si avvera, e lo sgomento davanti al tradimento di una fede si fa sorriso accorato, e palpita, senza tramonto, in pagine durature.
…………..L’improprio scampanio può divenire annuncio fiducioso. E se nel momento supremo
…….tengo stretta la tua mano di raso
…….per ricordarti che sono vissuta, inamovibile,
…….in quel sempre non ancora esalato
…….e che, solitaria, sarò ancora là
…….in quell’insostenibile mai più
poi la solitudine si riempie di pensamenti e di sconosciuti accarezzamenti, di un geloso custodire, ritracciare, perpetuarsi che conduce, se pure in altro vivere, all’insperata rinascita: ora sei di nuovo con me. Una resurrezione quasi naturale, da un lutto precocemente metabolizzato, dono – chissà – di quei giorni / che ti hanno ingrandito gli occhi / e ti hanno fatto fluire parole / che ti si erano calcificate nella gola.
…………..Il continuo parlarti che scivola / in un’amara pena senza risposta, sa bene, soffrendo, che la replica fu pronunciata e non può non risuonare ancora, a dispetto della corporeità che manca, se tuttora è capace di “mostrarti” il nido / che ho trovato nella murata del gelsomino. La vita, fuori, è di rondini nuove, di cori allarmati dei cani del quartiere; dentro, di un cuscino dove può sbiadire l’odore di una testa appoggiata, ma dal quale mai nessuno cancellerà l’impronta di un amato davvero “compagno di viaggio”.
…………..Come niente, tuttavia, potrà mai colmare il vuoto di una scomparsa insanabile, e insieme di una grave privazione: “Eppure non mi dà riposo / sapere che in uno o in due noi siamo una sola cosa” [1].
Nella silloge di Maria Vittoria il tema dell’amore, assolutamente preminente, anche se subordinato a quello precipuo della sofferenza, si svolge con originalità dall’incontro di intelligenze sensibili, per quanto “rabbiose”, che una volta a confronto rivendicano ciascuna la propria individualità, pur in una reciproca – difficile ad ammettere – cessione, senza la quale nessuna umana correlazione può avverarsi, dando vita ad un qualche legame. Ammissione-sofferenza, che induce rese e torvi pentimenti, pene da scontare in lunghi silenzi impenetrabili, ire che convivono con occhi buoni, il troppo non detto che non si accorge dell’altrettanto manifestato, la lotta interiore del bifrontismo individuale, ed esterna, ma solo per così dire, delle “quattro nature” che entrano in conflitto. Non credo ci sia per nessuno immunità da una profonda ambivalenza, dentro cui, invece, ognuno è costretto a dibattersi, e a battersi, poi, inevitabilmente, con gli altri. E la sofferenza di amare è prossima alla sofferenza del vivere stesso, perché non esiste passo verso conquista alcuna che non sia da percorrere lungo un’erta. Del resto come si può pensare che possa esserci estraneità, o luogo dei senza amore, o impossibilità di cum-prehendere la persona amata, se poi l’uno e l’altro possono compenetrarsi fino ad intridersi, se possono divenire inscindibili, fino a mancarsi senza rimedio al venire meno dell’altro o dell’uno?
…………..Paradossalmente la difficoltà di comunicare e di comprendersi, comune a tutte le relazioni umane, è l’unico ed efficace tramite, sia pure inconsapevole, di comprendersi e di comunicare, perché diversamente nessun amore sopravivrebbe mai a se stesso. Il muro dei silenzi e dei risentimenti, quando non è così granitico da dividere irrimediabilmente, è forse solo un utile ostacolo oltre il quale si affacciano le remote regioni dell’inconscio per vedersi, e per accostarsi… Maria Vittoria e L. hanno certamente varcato questa soglia, convenendo dove i diversi urtano e in quell’urto s’incontrano, confermando il presupposto di un connubio necessario, il convergere di nature difformi che proprio per esser tali consonano, chiudendo il cerchio finito ed infinito dentro cui anche gli opposti coincidono. In tal modo la coppia, per conseguenza ora “spaiata”, ha potuto rapportarsi, quel tanto che bastasse a sorreggere il sentimento, bello e non fugace, che qui si svela.
…………..Non altrimenti potrei spiegare, in questo piccolo volume di pregio, pervaso di poesia, il dolore feroce, eppure “virilmente” contenuto ed espresso, che subentra alla perdita di un “tesoro” impareggiabile, di un “amore” mai più trovabile. E mi si perdoni l’avverbio che potrebbe apparire irriverente in un’epoca che ipocritamente traduce la femminilità, nella sua essenza più profonda ed immutabile (das Ewig-Weibliche), nel fittizio riguardo ch’esige appena brutti sostantivi promiscui forzati al femminile per ossequiarla.
Il pregio della poesia – non della gratuita ‘parola versa’ – è quello di esprimere i sentimenti in infinite vesti d’infinite maniere, in rapporto alla varietà ed al numero degli artifici e alla molteplicità degli artefici.
……………Non v’è autentico poeta che non lasci impronte esclusive della sua specificità. Spesso, nella produzione letteraria, gli elaborati sono fedeli “autoritratti”, specchi dei lineamenti psicologici e perfino fisici dei loro autori.
…………..Anche in questa raccolta ogni pagina, ogni pensiero, a volte le singole parole, ripropongono genuinamente i tratti dell’autrice, nel suo modo di essere e di apparire.
…………..Sensibilità, raffinatezza, misura, essenzialità; parole asciutte per figure retoriche pregnanti; rinuncia all’elemento esornativo; movimenti lirici sorvegliati, che si sottraggono al sentimentalismo, ma si porgono densi di composta effusione; capacità di vedere sentendo o di sentire vedendo, magari brume / che imperlano / ciglia notturne, o campane di chiese / dai suoni bagnati, dove l’evidenziata sinestesia, da sola, illustra la simbiosi auditivo-visiva -e perfino tattile- delle sensazioni-sentimento; inattesi e suggestivi traslati, come i vetri d’abitudine, l’eccesso della rosa, la denuncia fatta di saliva, le trasognate pozze, il tramonto che si immerge nella pece.
…………..Il ritmo asseconda più l’andamento variabile interiore che la misura annunciata e costante della metrica classica; nondimeno è ineludibile il sotterraneo retaggio della più tipica e diffusa cadenza nostrana, come dimostrano alcuni endecasillabi, belli ed eleganti: occhi di smarrimento e di paura; cadesti sotto un maglio senza scampo; e sempre lo sarà da ville antiche; balenando un miraggio di salita; in quell’insostenibile mai più (verso tronco); con quel sogno annidato tra le dita; in molte notti misurate a passi [2]; molte altre notti di indivisi noi; nessuna radio turbina canzoni; di lisci massi e ovest di tramonti…
…………..Colpisce la scelta stilistica che ignora del tutto il punto fermo, quasi sbocco di un sentimento eracliteo, del tempo e del vivere, che non ammette pause, ma incessantemente reclama uno scorrimento e solo consente, o sottolinea, attraverso l’uso delle maiuscole o dell’interlinea più spaziata che contrassegna strofe disuguali, il respiro che cadenza vario, più lento, più lesto, prolungato, o per andatura ribadita, sia pure in aliti che si volgono in direzioni nuove. Unica eccezione: il verso iterato “Guardami, sono io.”, come per suggerire l’identità immutabile del soggetto nel “tutto scorre” delle cose.
…………..Fra questi “modi”, il cuore della fertile sofferenza, che dovunque palpita, soprattutto dentro le vene dell’amore, cerca incessantemente il sogno, unico ormeggio perché la vita non derivi, prima ed ultima attesa dell’esistenza, oltre cui diviene insostenibile “trascorrere”.
…….“Se smascheri un sogno
…….il sogno muore e, per vivere,
…….io ne ho ancora bisogno”
…………..Necessità…
dell’illusione magari di contrastare il tempo in cui non saprò più / i contorni del tuo viso; di una finzione, ad occhi chiusi, abbracciata ad un “surrogato” dal morbido silenzio, cui promettere altre notti di indivisi noi.
Amato Maria Bernabei
[1] Eugenio Montale, Satura, Xenia I, 14.
[2] La lirica “Surrogati” è tutta in endecasillabi.
* * * * * * *
La prefazione di Stefano Valentini
A Maria Vittoria Scaramuzza mi lega oltre un decennio di amicizia, inizialmente nata dalla stretta collaborazione necessaria per organizzare il Premio di poesia e narrativa «Vigonza»: una manifestazione di livello qualitativo alto e riconosciuto, nella quale lei ha incanalato la passione e il talento creativo che in questo libro, finalmente, si rivelano come espressione personale e autonoma. Una rivelazione, tuttavia, che forse non ci sarebbe mai stata, non si fosse verificata la tragedia di un lutto che ha diviso la sua esistenza tra un “prima” e un “dopo”, il prima di quando Luciano era presente e il dopo – l’adesso – della sua assenza.
Ho ritenuto giusto riassumere subito queste circostanze che rappresentano, per cosi dire, lo scenario esistenziale della poesia di Maria Vittoria, ma la mia nota non cederà all’impulso di trasformarle in ragioni interpretative. Per quanto importanti, e senza alcun dubbio lo sono, ritengo infatti che questo libro vada apprezzato in quanto tale e senza il continuo rimando alle sue motivazioni. Tutti i libri hanno un perché, ma molti in quel perché quasi si esauriscono: qui la poesia, a mio giudizio, rappresenta invece un valore assoluto che non necessita di trovare sostegno, né ancor meno giustificazione, in considerazioni biografiche.
Motivo portante, comunque, è l’inevitabile dicotomia tra vita e morte: ma con un sottile, decisivo arricchimento, espresso nella citazione (da Bob Dylan) anteposta al testo. Il richiamo ad “essere impegnato” non ha nulla di ironico e rimarca, invece, una effettiva attitudine: impegno come negazione della passività; quale che sia la sua direzione. Adesione alla vita oppure suo contrario, ma non per abbandono né inerzia. Ecco, precisamente in un simile esercizio attivo della volontà si trova una chiave di volta di questa scrittura, risoluta ad esplorare fino in fondo quanto accade, fronteggiandolo senza languore né struggimento. La poesia di Maria Vittoria – Vicky – non sfugge, non si ripiega, non si consola in se stessa né in altro: una determinazione che si risolve in nitore comunicativo perché, come è noto, per esprimere concetti con chiarezza è necessario averli ben chiari innanzitutto a se stessi. Vale per qualsiasi discorso, anche per quello poetico.
Pertanto lo stile, personale, risulta denso e accurato ma non fuorviante, non compiaciuto: l’efficacia tutta nella forza della parola, non in architetture mirabolanti. Tocca l’anima perché dall’anima proviene, strappandosene letteralmente, con una emotività controllata - per pudore, coscienza, sapienza – e tuttavia intatta nel suo coinvolgimento. Non abbiamo, in realtà, le parole giuste per dirlo, perché oltre un certo limite la poesia non può essere ingabbiata in descrizioni: quando c’è, quando si realizza il prodigio della comunicazione che da verbale si proietta ad un livello differente, la si sente e basta, come avviene qui in ogni pagina. Né il critico può, di suo, aggiungere più di tanto: questa poesia non va interpretata, non presuppone contenuti inconsci né invoca decifrazioni di chi sa quali arcani interiori. Quello di cui parla è dichiarato, palese, incarnato in una realtà senza trasfigurazioni oniriche o allegoriche e, dunque, a tutti comprensibile.
Il protagonista di tutto il libro è il tempo. Ma vale quanto già accennato: nella scrittura il ricordo, il passato, l’evocazione si accompagnano solitamente ad una malinconia sentimentale da cui la poesia di Maria Vittoria appare del tutto immune. Per lancinante che risulti la sofferenza è fertile, come dice il bel titolo della raccolta, e ciò che è fertile non langue. Lo scandaglio introspettivo non è autoreferenziale, neppure quando la solitudine appare invincibile e il sé si staglia come unico soggetto disponibile: la propensione narrativa e la necessità di “raccontare” inducono non alla commemorazione, bensì al confronto – sia pur dolente – con quanto ancora rimane dei giorni che sono stati.
Il ricordo, qui, non appare intriso di lacrime, che pure hanno certamente e legittimamente preceduto il momento della scrittura: ha invece gli accenti risoluti della testimonianza, come dimostrano le “poesie del ricordo” e quelle per Luciano. Gli assenti non sono spettri e, anche se la memoria non basta a renderli di nuovo presenti, il limbo nel quale sono confinati rappresenta comunque, in modo misterioso, un livello di realtà. Né luminoso né infero, come tutto ciò che si muove in queste pagine: l’assenza di una prospettiva ultraterrena congela il discorso in un immobile presente, dove non esiste attesa o, se pure esiste, non si lascia definire in una forma. Il senso di ciò che è stato, allora, è tutto in quel che è stato, non in qualcosa che ancora possa essere: eppure, vedremo, non vi si esaurisce.
La raccolta si apre con un gruppo di poesie definite “d’annata”, a significarne la composizione lontana nel tempo. Rappresentano l’omaggio ad una città, Vigonza, dove “sono stata felice e triste più che in ogni altro luogo”, come annota nella brevissima nota biografica. Una polarità di sentimenti dovuta ad uno spazio vitale concentrato nella geografia ma vastissimo nell’anima, sentendosi “una cellula / che non risponde / mansueta al tuo codice”: dunque un’appartenenza, sia pure acquisita, e nel contempo una sensazione di spaesamento, un desiderio di radici e di casa impossibile da realizzarsi fino in fondo.
Le descrizioni sono sintetiche, come dev’essere in poesia, e tuttavia accurate, quasi fosse necessaria la definizione di una topografia esteriore a sorreggere quella interiore, ambita e ardua. Grande rilievo assumono le presenze vegetali e floreali, realtà effettiva nella quotidianità di Vicky come ben sa chi abbia visitato, almeno una volta, quel piccolo giardino pensile che è la sua terrazza. Ed è una vegetazione in cui appare lecito specchiare la condizione umana, dal basilico che “mai aveva avuto / tanto profumo / come mentre moriva” all’ibisco con la sua “magnificenza”. C’e spazio, persino, perché baleni qui e là un delicato lirismo, al quale l’autrice non indulge ma che, con sapiente misura, neppure disdegna: “Tornata dall’incognito / percorro la strada d’oro / filata dai ragni / tra foglia e foglia / della mia siepe // Senza pensiero, seguo / la danza nel sole / di mille ballerine di bambagia / figlie dei pioppi”. La natura avvolge e trasfigura i giorni, rivelandosi ben più di una semplice cornice o di un ornamento.
Del resto di ornamentale, qui, non c’e proprio nulla: tutto è essenziale, anche quando minimo, anche quando sembra soltanto un lacerto colto in maniera all’apparenza casuale. In tale scenario s’affacciano individualità e relazioni umane, “l’appassito ricordo / della fatica caparbia / di volerti, tuo malgrado”, oppure l’”adulto bambino / con cui ridevo tanto / nei giorni del sollievo / e che poi cullavo / nel tempo della follia”, o ancora il giovanissimo soldato tedesco ospitato a tavola in un Natale di guerra, in quell’età infantile la cui “inconsapevole grazia” è ormai perduta per sempre. Ma, per quanto soccorra, è del tutto insufficiente il rifugio nel sogno (“in un nord lontanissimo / dove il mondo finisce”), né basta scrivere di ciò che è stato: “mi è urgente la vita / per liberarmi dalle spire / della sola teoria”, quella vita che compensi le parole rivolte “sempre più piano, / alla tua schiena opposta / come un no definitivo”.
Emerge qui una dimensione fondante della poesia di Maria Vittoria Scaramuzza, l’amore che non trova adeguata risposta né appagante riscontro e “fatica a crescere / come un fiore tardivo / colto da inaspettate / e sconosciute intemperie”. Un bisogno d’amore che non ha nulla di banalmente romantico, ma è aspirazione al dialogo tra anime e intelletti, necessità vitale e spesso, troppo spesso, inappagata. E il “luogo dei senza amore / cui duole la carne intoccata / ed il pianto indiviso”, un “deserto in cui dilagano / desolati mattini” che assume contorni di dolente ferocia (si legga “Ordinaria domenica”) e d’amaro disincanto verso la “fragile pochezza / della qualità umana”.
Arrivata fin qui, Vicky sospettava che la poesia l’avesse abbandonata.
Ma, pur tentata dalla resa, l’anima rimane “dolce e guerriera”. Ci vogliono infatti tenerezza, e forza, per fronteggiare le memorie evocate nella seconda parte del libro, costituita di sei “poesie del ricordo”. Ci troviamo, qui, nel terreno più congeniale all’autrice, un narrare in versi che riassume e rende giustizia, per quanto può farlo la poesia, ad esistenze intere. Pochi cenni fondamentali resuscitano, dalle quinte del tempo, figure importanti alle quali la vita, con maggiore o minore durezza, ha imposto il suo giogo e le sue leggi impietose. Albertina la cui madre morì “credo convinta” per la continua umiliazione d’esser considerata “vergogna di famiglia”, lasciandola sola e abbandonata; Linda, bella come una diva del cinema e amica carissima, la cui mente è vinta dalla senescenza; Luisella dalle vicende ripetutamente sfortunate, ma tuttora sorretta dall’amore; Elena divenuta, con l’età, aspra e adirata, ma il cui canto è ancora nitido nella memoria; Eva dall’esistenza intensa, e a tratti scomposta, conclusa nel modo più banale. Sono vite segnate da lutti e tragedie, della cui esclusione diventa paradigma una nobile residenza quasi inaccessibile: “il mondo che, insomma, era al di fuori / e sempre lo sarà da ville antiche / in fondo a strade che mimano la vita / balenando un miraggio di salita”. Nella colloquialità del dettato, intenzionalmente piano e (appunto) narrativo, si annida e risuona un’intensità che coinvolge e commuove, pulsante di umanità, compassione e condivisione autenticamente sentite e assolutamente non di maniera.
La sezione del ricordo prelude al cuore tematico del libro, dov’è racchiuso ciò che deve essere detto nonostante, in quei momenti, tutto suggerisca che non esistano parole per dirlo. Il lutto spezza la vita in due, in un prima e un dopo, tra un “tu” presente e un “tu” assente. La poesia, per propria natura, vorrebbe istintivamente ricucire tale separazione e distanza, proponendosi l’impossibile: scendere nel regno delle ombre e riportarne, qui, una qualche luce. Ma ogni consolazione, ogni abbellimento risulta impossibile, già dal fremente inizio: “Il nostro mondo era fatto / di intelligenza rabbiosa, / di elevati contrasti / e diffidenti tue rese”, in un alternarsi di incomprensioni e di silenzi, di affetto non dimostrato, di un “immenso taciuto” che solo adesso è “appassionatamente vinto”. Non c’entra la poesia in questa vittoria, beninteso, perché la sua funzione non é redimere il passato. Le risposte vengono dagli occhi, dai gesti, dalle “parole laceranti”, in una sequenza stranita e straziata. Sono poesie che documentano un accompagnamento verso la fine, immersa in un “sempre non ancora esalato” e in attesa di un “insostenibile mai più”, dense di una verità che non ha nulla di celebrativo e cerimoniale, assolutamente nulla di rituale e di retorico. Nate nell’immediatezza della perdita, risultano sconvolgenti per profondità e fermezza, immerse nell’assenza che è ancora presenza ma non in ragione di aspettative ultraterrene, bensì di quella permanenza di cui sono espressione gli oggetti, le stanze, le memorie. Ma la sincerità non fa sconti: “Se non fosse per quei giorni estremi / bastanti a far dimenticare l’offesa…”, a suggerire come la morte induca a rileggere molte cose sotto una nuova luce ma non basti comunque, in sé, a cancellare il dolore e l’incomprensione che sono stati.
Non c’e lutto che non ceda, in un modo o nell’altro, alla vita, in qualche forma che non è mai banale, mai stereotipa, mai prevedibile o scontata. Servono sortilegi, surrogati e rimozioni, evocati in tre gioielli poetici davvero magnifici, e non è certamente un percorso facile, “la fatica sarà ancora solitaria e tortuosa” attraverso “giorni lunghi ognuno un secolo”. Nelle poesie che chiudono il libro si trova la chiave per decifrarne il titolo, che non mira a valorizzare il dolore (né, men che meno, a “santificarlo”) ma, semplicemente, a prendere atto delle sue conseguenze. La compostezza è quella di chi non spera ma neppure dispera, non per una sopraggiunta atarassia, ma per naturale attitudine e forza interiore che neppure lo sfacelo dei propri riferimenti riesce a dissolvere. Una “serena disperazione” molto differente da quella formulata da Saba, ma altrettanto lucida nell’analizzare passato, presente e futuro per orientarsi in un mondo “che prima non esisteva”, nel quale nessuno “sa nulla del nostro insieme”.
Soprattutto, lui ha recuperato il suo nome, come raccontato e spiegato nel piccolo capolavoro che è “Folletti d’amore”, punto di svolta ed esorcismo d’ogni residuo timore, primo tentativo di effettiva riappropriazione di un sé che non dimentica, ma è disposto ad apprendere: “Spaiata, io sono rimasta in questo mondo / e, incerta, provo i passi per capire / i gesti di ogni giorno”. C’è, in queste parole che si confrontano con l’ombra senza lasciarsene sedurre, molto dei migliori tra gli Xenia montaliani, vertice contemporaneo della poesia di lutto: l’evocazione di una grande autrice novecentesca, Sylvia Plath, non è allora un transfert né un suggello ma una sorta di sorriso complice, da donna a donna, una trasfigurazione - addirittura velata d’ironia, per nulla irriverente – che è, davvero, pronta a tutto. Ben prima che altri sanguinino versi per te sarai tu a scriverne ancora, cara Vicky: perché “neppure di morte si può / scrivere all’infinito” e ad essere fertile in te non è soltanto la sofferenza, ma l’intero tuo essere in questo mondo che - con la tua persona, le tue azioni, il tuo impegno, la tua poesia – tu rendi, puoi credermi, migliore.
Stefano Valentini
La Nuova Tribuna Letteraria
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Recensione di Mario Klein
Direttore del mensile in lingua veneta “Quatro Ciacoe“
El profuma ancora de inchiostro fresco sto secondo libro de Maria Vittoria Scaramuzza: el xe nato da poco (otobre 2013) e el xe za stà batesà (el 7 marzo 2014, al castelo de i da Peraga). Se trata de na “creatura dello spirito” belissima, rafinata, elegante, distinta quanto la stessa persona – la poetessa – che ghe ga messo ne le vene el sangue de la poesia più vera. Na poesia che xe fadiga definire, descrivare, pesare, valutare: na poesia, comunque, de grande qualità, na trasfigurassion de la parola che va solo gustà co i oci de l’anima, par el so codice espressivo, per la forza interiore e la magnificenza del verso, senpre lì, pronto a incantarte con la novità de l’imàgine, con la puntualità de la luce che ilùmina la trasparenza del tempo e la so onbra.
La fertile sofferenza (Venilia Editrice e Valentina Editrice, prefassion de Stefano Valentini, 64 pagine, 40 poesie, Euro 12,00) conpagna da vissin l’umana perplessità de l’autrice, lungo el percorso sapiente del vivare con tute le so varianti, che se sa ben come che le xe: de le volte entusiasmanti, de le altre le te tole el respiro, le te còpa la speranza.
Eco alora che la poesia de Maria Vittoria se fa testimoninza non de on solitario lamento, ma de na coragiosa analisi per rimétarse in piè e recuperare la voja de inpegnarse a vìvare, anziché inpegnarse a morire. Miracolo de la “sofferenza”, miracolo de la poesia. (M.K.).
.
.
.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
CHIARI (BS): MICROEDITORIA 2014
1° Premio Sezione Poesia
 “La poesia di Maria Vittoria Scaramuzza si caratterizza come un’operazione di scavo profondo e impietoso che la poetessa vuole effettuare entro le ferite del proprio vissuto senza però mai cedere alla tentazione dell’urlo disperato o alla scorciatoia consolatrice del pianto. Queste due tentazioni estreme, pur incombenti ad ogni verso, sono volutamente inibite per poter dare spazio e voce a quella fertile sofferenza, entro il cui spazio potrà muoversi silenziato, ma non per questo privo di poetico vigore, quel racconto di vita così totalmente immolato a se stesso.
“La poesia di Maria Vittoria Scaramuzza si caratterizza come un’operazione di scavo profondo e impietoso che la poetessa vuole effettuare entro le ferite del proprio vissuto senza però mai cedere alla tentazione dell’urlo disperato o alla scorciatoia consolatrice del pianto. Queste due tentazioni estreme, pur incombenti ad ogni verso, sono volutamente inibite per poter dare spazio e voce a quella fertile sofferenza, entro il cui spazio potrà muoversi silenziato, ma non per questo privo di poetico vigore, quel racconto di vita così totalmente immolato a se stesso.
Con questa premessa la poesia che ne consegue accoglie entro di sé gli esiti di una battaglia spenta ma mai persa, di una delusione che ha l’identico monotono respiro dello scorrere dei giorni, di un paradiso spiato solo per un attimo e smarrito. Ciò che resta alla fine sono solo oggetti, profumi, colori, il ricordo dei sensi. Essi conservano indelebilmente la facoltà di riprodurre ciò che è stato, un rimembrare struggente di affetti che ci hanno accompagnato e sovente illuso. Alle mani impalpabili e generose della poesia il compito poi di scavare, raccogliere e restituire. Senza andare troppo oltre, però, perché le grandi domande trascendentali su chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, qui non hanno ragion d’essere. Qui, dietro una porta che non si apre mai, ciò che conta è farsi amica la sofferenza in attesa che, da qualche parte, l’amore perduto si accorga di noi e ci venga ad abbracciare”.
Chiari, 7 Novembre 2014
_ _ _ _ _ _ _ _ _
La fertile sofferenza (alcune liriche)

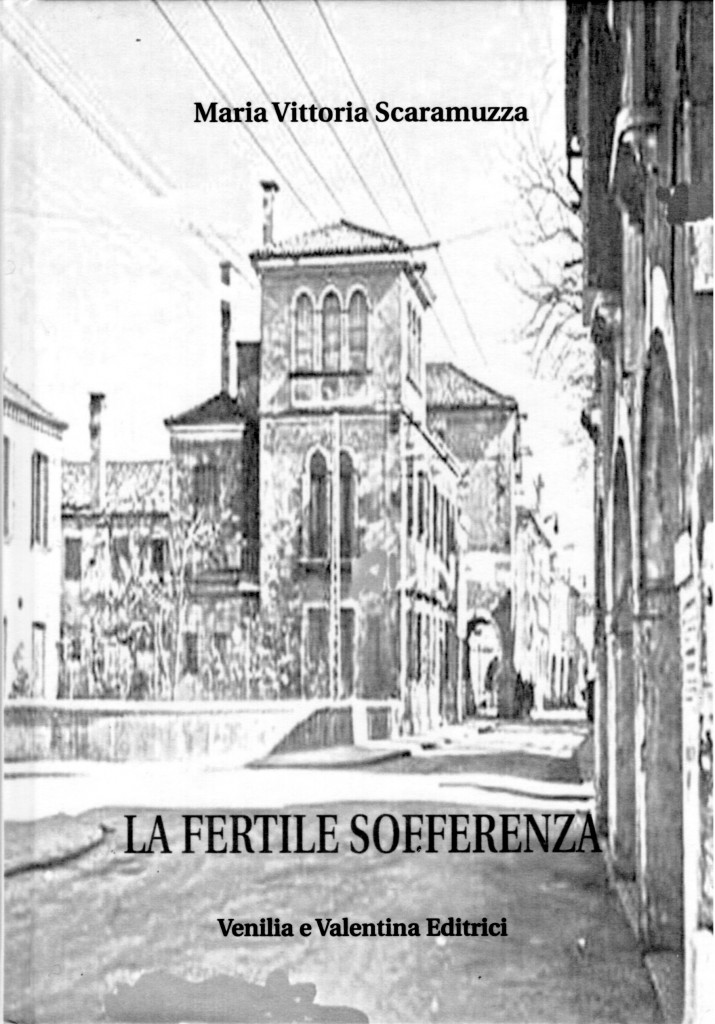


*

To prove that you're not a bot, enter this code