Troppi libri sono concepiti solo per lo smercio!
Avevo inviato una breve recensione del saggio di Stefano Bollani, Parliamo di musica, al sito ibs.it, con lo pseudonimo di eppursimuove, e devo ammettere la mia sorpresa nel constatare che il mio parere, non certo positivo, è stato ospitato. Ritengo adesso opportuno pubblicare sul mio spazio un’ampia scheda che giustifichi il giudizio sfavorevole riportato di seguito:
“In teoria tutto è musica”, scrive frettolosamente Bollani, come quando qualcuno dice che tutto è poesia; ma musica e poesia sono arti e, in quanto tali, prodotti convenzionali di alta levatura (quando sono Musica e Poesia) che non esistono “in natura”, come vorrebbe il pianista. Uno dei tanti esempi possibili di idee vergate là, per riempire la pagina.
Ho trovato il volume del pianista piuttosto inutile, gradevole solo nella narrazione aneddotica. Il classico testo che viene commissionato per il mercato a chi, per essere noto, procurerà vantaggi a se stesso e alla casa editrice. Scrittura rabberciata, con errori non infrequenti (anche di grammatica, come “un altro elemento… sono quelle…”). Alcuni argomenti sono intitolati ed, a mio avviso, non trattati (cosa che accade, ad esempio, nel capitolo “E parlare di cultura?”). Stile a volte confuso, incoerenza di pensiero o mancanza di attitudine ad esprimerlo in modo chiaro; argomentazioni perfino incongrue.
Insomma, la consueta sortita del personaggio mediatico che non ha l’indole dello scrittore, ma che ad ogni costo deve pubblicare il suo libro.
Di gran lunga migliore il Bollani musicista.
Questa la mia opinione, in sintesi. Ora approfondisco, non senza aver prima ribadito la mia grande stima per lo strumentista.
Parliamo di musica (Mondadori) è, dunque, il titolo del “libro” di Stefano Bollani.
 Letterato? No, jazzista e compositore noto, perciò, di necessità, anche scrittore. Naturalmente per un marchio “rinomato” (ormai più noto che pregiato) come Mondadori. Sarcasmo? Sì. Del resto questo è il tempo in cui chi sa veramente scrivere e non è personaggio mediatico, può tenere nel cassetto le sue pagine, mentre chi ha acquisito fama per qualunque ragione possibile, può estrarre dal cassetto anche le pagine che non ha.
Letterato? No, jazzista e compositore noto, perciò, di necessità, anche scrittore. Naturalmente per un marchio “rinomato” (ormai più noto che pregiato) come Mondadori. Sarcasmo? Sì. Del resto questo è il tempo in cui chi sa veramente scrivere e non è personaggio mediatico, può tenere nel cassetto le sue pagine, mentre chi ha acquisito fama per qualunque ragione possibile, può estrarre dal cassetto anche le pagine che non ha.
Il libro del Bollani è uno dei tanti esempi che rafforzano il detto “chi vuol fare l’altrui mestiere fa la zuppa nel paniere”, per colpa di una logica che assegna i ruoli in relazione al commercio e non alle competenze. Come se un degno e conosciuto poeta, per il fatto stesso di essere tale, strimpellando il pianoforte si sentisse autorizzato a pubblicare un album di musica jazz. Credo che se io lo facessi, avresti ben da ridire – e con ragione – caro Stefano! Mi si dirà che un musicista ha pieno diritto di parlare e scrivere di musica. Certo: ma la stesura di un libro richiede attitudini specifiche. Bravura linguistica, ad esempio, capacità di argomentare con logica, coerenza, proprietà, precisione… Doti che non ho potuto riscontrare in modo apprezzabile nel volume del pianista milanese, in cui mi sono imbattuto per caso, nei miei percorsi digitali.
Ho letto, e posso affermare in modo deciso che di Bollani preferisco le interpretazioni al pianoforte e che il musicista avrebbe fatto meglio a dedicare alla sua arte il tempo speso nella “scrittura”.
Il volume si apre con una considerazione sui gusti musicali “indiani” che impediscono a un amico dell’autore di apprezzare il bellissimo, a mio avviso, brano dei Beatles Yesterday, e per il quale gli espedienti melodici degli autori, le “scale”, in particolare, sarebbero «orpelli di una popolazione “civilizzata”» per lui difficili da capire, abituato com’è ai raga [1].
Il Bollani nota in proposito che “la scala ascendente di Yesterday ci commuove perché le note che salgono ci comunicano una tensione (e se scendono ci mettono tristezza)”. Cosa che certo non può essere generalizzata, dal momento che esistono tanti brani in cui ciò non si avvera (mi vengono in mente scale ascendenti e discendenti, in successione, che in certe sinfonie di Rossini hanno tutt’altro risultato). A parte la contraddizione con quanto Bollani sosterrà a proposito degli effetti psicologici degli accordi maggiori e minori [2], non credo che basti salire e scendere per il pentagramma per generare tensioni e tristezze. Yesterday comunica quel che comunica per il suo insieme, per la sua gestalt, fatta di melodia, armonia, ritmo, dinamica… Un risultato estetico è frutto della fusione dei mezzi usati, in vista dell’espressione di uno stato d’animo e di una filosofia di vita, non si può ridurre a nessun singolo elemento e nemmeno alla somma degli elementi medesimi. Se imprimessi a una melodia, identica nelle note, un altro andamento modificando le figure, cambiassi anche solo in parte l’armonia, creassi una diversa cadenza ritmica, magari molto più incalzante, già l’esito sarebbe di gran lunga diverso, e magari la nostalgia si trasformerebbe in allegria, nonostante il salire e il discendere delle note sul pentagramma.
Se poi in un orecchio abituato ad altro genere differenti modalità suscitano fastidio, forse quell’orecchio non è così sviluppato e ricettivo da poter apprezzare la diversità: la buona musica non ha lingue né continenti. Io non trovo noiosa una bella musica indiana solo perché distante dai canoni cui sono abituato, né disprezzo la poesia azteca perché sono aduso a leggere il Petrarca! Trovare noioso un vero prodotto artistico è una restrizione della sensibilità e dell’intelligenza. Qualunque visione settoriale è limitante, anche quella di chi si è abituato ai raga indiani ed è ottuso ad altre modalità. E in realtà Bollani afferma che “questa visione della musica limita le nostre possibilità di ascolto”.
Subito dopo, però, si produce in una sconcertante affermazione, scrivendo che “la musica è un po’ come la democrazia”! Accostamento che sembra reggere per argomentare l’angustia di un singolo approccio di fronte alla ricca molteplicità delle esperienze possibili, perché la democrazia vera è apertura e le aperture non hanno steccati o, quanto meno, superano la recinzione attraverso uno sbocco, ma che diventa “opaco” quando l’autore continua con il dire che “la democrazia non è l’unico dei mondi possibili” e conclude in modo confuso che “la musica esiste in natura”, chiedendosi quale sia “il confine tra musica e rumore”. Non proprio un incedere rigoroso!
Senza soffermarmi sull’evidente disordine, mi preme rilevare la confusione semantica circa la parola “musica”. Siamo al solito equivoco che nasce dalla polisemia. Si sovrappongono, nell’argomentazione di Bollani, almeno tre significati del termine “musica”: quello figurato di armoniosa sensazione auditiva, quello metonimico di suono, quello proprio di arte. In relazione a quest’ultima accezione mai nessuno potrà sostenere che la musica (oggetto del conversare dell’autore) esiste in natura; affermazione valida, invece, per il secondo significato e in parte per il primo, assegnabile anche a un prodotto artistico. Il garbuglio è evidente quando Bollani si interroga sulla differenza “fra musica e rumore”, distinzione improponibile se non intendiamo il vocabolo musica come suono, per sineddoche! Immaginate se io dicessi che la poesia esiste in natura solo per il fatto che la natura può essere poetica, può avere poesia intesa come motivo di ispirazione e di idealizzazione (la poesia di un’aurora). Le arti sono invece il frutto di artifici umani e rispondono a umane convenzioni (e convinzioni). In natura esistono suoni, ma nessuna grammatica dei suoni (e questo, nel marasma, il Bollani lo dice); ci sono scenari poetici, ma nessuna grammatica della parola: in natura non c’è, né mai ci sarà, l’arte.
Un sofisma è possibile: l’uomo è parte della natura ed ogni sua creazione è “naturale”, perciò l’arte, attraverso l’uomo, è in natura. Chiunque abbia buone capacità logiche può rendersi conto della fragilità di questo capzioso ragionamento a sostegno del concetto bollaniano.
Il pianista però rafforza la confusione al capoverso successivo, quando decreta: “In teoria, tutto è musica”. Poi parla della musicalità del canto degli uccelli che noi valuteremmo in forza del sistema tonale occidentale, al punto che si dovrebbe pensare che un indiano debba essere insensibile al verso di un usignolo. Si precisa però che anche i pigolii distanti dai gusti “etnici” sono musica. Ribadisco la caduta del musicista in un minestrone polisemico senza via di uscita. Il canto degli uccelli può essere musicale, o “musica” per i nostri orecchi, ma non lo si accosti nemmeno all’arte della Musica!
Si può indugiare, a questo punto, su alcune righe gratuite del saggio: “Magari proprio quelli [gli uccelli] che si distanziano maggiormente dai nostri parametri di bellezza stanno eseguendo un richiamo d’amore dolcissimo, o un lamento di dolore”… Che si dice in sostanza della musica? Proprio niente. L’umana interpretazione non ha nulla a che vedere con i fenomeni naturali. Il richiamo di un’upupa può essere d’amore (ma ha senso parlare d’amore per un volatile?) o di sofferenza, avrà sempre sull’uomo un effetto diverso dai segnali di un canarino. Credo che non sia casuale che il verso del primo abbia suggestionato i poeti preromantici portandoli a farne un “suono” sepolcrale e finendo nel Carme di Ugo Foscolo (e uscir del teschio, ove fuggia la luna, / l’upupa, e svolazzar su per le croci). È l’uomo che stabilisce se un cinguettio gli pare dolce o sgradevole, e non certo in relazione ai sistemi musicali!
A margine delle considerazioni che riguardano il canto degli uccelli si legge poco più avanti (ma il nesso sfugge): “Recentemente si sono fatti degli esperimenti all’asilo con alcuni bambini facendo loro ascoltare un pezzo di John Cage e Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, e i bambini hanno scelto John Cage…”. Altro che la scoperta di Cristoforo Colombo! Se ai bambini dell’asilo facciamo ascoltare Dante e la filastrocca della nonna, che volete che scelgano? Chiaro che i rumori e le “cose buffe” della musica di Cage debbano attrarre un bambino di tre anni più della musica di Vivaldi. Ma Bollani considera didattico l’esperimento: esso insegnerebbe che crescendo si rischia di “dare importanza solo alla grammatica, alla logica e alla tonalità [...] all’ordine, “e ciò che non è ordinato ci sembra strano”. Espresso così il concetto è facilmente contestabile: forse che il disordine è compatibile con l’arte?
L’autore voleva magari parlare dell’écart [3], della violazione del codice del linguaggio, più che del disordine vero e proprio, tant’è che in modo più chiaro, dopo qualche capoverso, egli aggiunge: “Tuttavia, senza queste deviazioni di percorso la musica non sarebbe andata avanti. E il jazz è sfacciatamente pieno di meravigliosi errori grammaticali”. Farò notare che lo “scarto”, la temporanea e voluta trasgressione alla norma, non necessariamente deve denominarsi errore.
Disarmante, nel capoverso successivo, il ragionamento per assurdo: “Dovremmo prendere un bambino e farlo crescere nel silenzio di una foresta e poi vedere [vedere?] che musica produrrebbe”. Beh, dopo essere stati indotti a ritenere che tutto è musica, risulta arduo pensare a una foresta completamente silenziosa. Ammettiamone l’esistenza: che musica produrrebbe un bambino cresciuto in isolamento in un simile ambiente? Marina Chapman, fra i cinque e i dieci anni, imparò ad urlare con le scimmie [4]: nel silenzio totale che “musica” potrebbe apprendere e produrre un bambino? Nessuna. In qualunque contesto il silenzio è pausa, mai suono. La metafora che sente la “musica del silenzio” sa di godere dei fruscii e delle flebili voci dei romitaggi, o allude alla capacità umana di ‘evocazione nella tranquillità’, nella pace, alla possibilità di… scrivere tutto su una pagina bianca… Ma immaginare che un bambino, privato dell’esperienza dei rumori e dei suoni, potrebbe essere più creativo, perché non condizionato da schemi precostituiti, mi pare contrasti con la stessa esigenza espressa dal Bollani di un’educazione alla musica (ti insegnano a leggere, ma non ad ascoltare la musica); come contraddittorio è il rimpianto della primitività libera da norme (niente regole sui rami degli alberi), che però non tiene conto che lo stesso rifugiarsi sulle piante di alto fusto e nascondersi tra le fronde costituiva “regola” per sottrarsi ai pericoli degli assalti improvvisi delle fiere, nel sonno.
Lascia perplessi anche l’affermazione che precede questa “nostalgia del passato”: “Tutto può essere musica. Non esiste in natura un sistema per distinguere il suono dal rumore”. Circa l’equivoco nell’uso del termine musica, è stato già detto. Per quanto concerne il problema dei suoni e dei rumori, la “natura” non può avere certo sistemi atti a distinguere i suoi fenomeni, ma la fisica conosce perfettamente la differenza tra le vibrazioni regolari di un “suono” e quelle diseguali di un rumore. Sicché la diversità degli eventi sonori non va riferita esclusivamente alla percezione soggettiva, che classifica il fenomeno acustico in relazione alla gradevolezza o al fastidio che esso genera, ma deve tener conto delle caratteristiche oggettive degli eventi medesimi, separare cioè il campo di studio della psicoacustica da quello dell’acustica.
Il nesso tra i vari livelli di ragionamento (alberi, musica, suoni e rumori) è comunque sfuggente, e per eufemismo.
Incoerente risulta pure affermare, a metà dell’opera, “quando i musicisti occidentali chiamano l’eschimese o l’aborigeno a incidere il risultato è kitsch”. Tenendo conto che si teorizza la libera interpretazione (ognuno suoni come vuole), il giudizio riportato sembra smentire l’assunto. Criticare la rigidità e indicare modelli da seguire non è sintomo di consequenzialità.
Nel capitolo “Imparare la musica” Bollani sostiene che un buon maestro “non fa studiare le stesse cose” a tutti i suoi alunni, e forse, con maggior precisione, vuole alludere alla necessità di variare il modo e di adeguare i contenuti in maniera individualizzata. Per quanto concerne “le cose” da studiare, esse non cambiano certo granché all’interno di una determinata disciplina!
Poi il musicista accusa una disarmante inesperienza: gli ricordiamo che prima di scrivere ci si documenta!
Egli riferisce: “La solita mitica équipe di scienziati inglesi, che forse esiste solo nella fantasia dei redattori di certi quotidiani, chissà, ci ha fatto sapere che il contenuto delle nostre frasi conta, in caso di comunicazione diretta fra due persone, diciamo un 20%”. Caro Bollani, non si tratta di scienziati inglesi, e non è corretto quello che riferisci.
Fu uno studioso statunitense, Albert Mehrabian, a pubblicare nel 1972 il volume Nonverbal communication, in cui riferì del suo studio sull’importanza dei livelli analogici (paraverbale, legato alla voce e al suo uso, e non verbale, connesso con gestualità, postura, mimica facciale) nella “comunicazione faccia a faccia”, stabilendo le percentuali di incidenza: livello paraverbale, 38%, livello non verbale, 55%, livello digitale o verbale, 7% [5].
Ricorda, caro Bollani, che ogni frettolosa scrittura di personaggio mediatico, scade in divulgazione d’ignoranza! Responsabilità non trascurabile, evidentemente.
Mi preme a questo punto evidenziare un genere veniale d’imperfezione, che tuttavia contribuisce a dare la misura dell’approssimazione del jazzista nella stesura dell’elaborato. Si incontrano di tanto in tanto, nel suo libro, espressioni poco accurate, come: “In natura, tra il Do e il La, ci sono mille altre possibilità, mille sfumature”, per significare che tra i suoni che noi abbiamo deciso di chiamare La e Do, ce ne sono infiniti altri di frequenza crescente. In natura ci sono fenomeni, non criteri di accordo e denominazioni. Oppure si legge: “Il La era un’altra nota”, per farci sapere che il suono emesso dal diapason (o corista) è stato oggetto di convenzioni diverse: nel 1885 la piccola forcella d’acciaio era stata intonata sulla frequenza di 435 hertz [6], che successivamente sarebbe stata innalzata a 440 e poi a 442; il La, dunque, non era “un’altra nota”, il Fa o il Mi, o il Sol: aveva semplicemente, per convenzione, caratteristiche leggermente diverse, un numero di oscillazioni al secondo di appena l’1,6% inferiore!
Continuando: “Nella musica classica le dinamiche pretendono un ascolto impegnato”… Forse a Bollani sfugge la distinzione tra il participio passato di impegnare e l’aggettivo impegnativo? Come può un ascolto essere impegnato? nel fare che?
Una banalità, se non un’imprecisione, mi sembra di poter rilevare nel passo in cui si parla della “musica di Profondo rosso, dei Goblin”. Il testo recita in proposito: “Dove è la terza minore, il Do, a conferire la tonalità minore”. Che novità! È sempre la caratteristica a contraddistinguere il modo. L’autore vuole dire probabilmente che, fino al momento in cui essa non viene eseguita, il modo non è individuabile; ma allora avrebbe dovuto usare un altro verbo, non ‘conferire’: magari rivelare.
A questa famiglia di negligenze appartiene anche la considerazione: “[l'orecchio assoluto] è utile non solo per accompagnare i cantanti che vogliono suonare il tal brano in una tonalità distante da quella originale, ma anche per accorgersi che lo stesso brano suonato in una tonalità più alta o più bassa rivela tutt’altro carattere”. A “i cantanti che vogliono suonare” avrei preferito “i cantanti che vogliono eseguire”, perché non tutti i cantanti suonano, mentre a tutti i cantanti capita di dover adattare la tonalità di un brano alla propria estensione vocale. Voglio credere che metaforicamente Bollani pensasse al cantante che suona il suo “strumento vocale”… Per di più ritengo che non sia necessario l’orecchio assoluto per accorgersi del diverso carattere che un pezzo musicale acquista quando viene mutata la sua tonalità originaria. Io ho l’orecchio relativo, ma avverto immediatamente una differenza del genere.
Tra le gaffe veniali si annovera anche questa: “Marsalis per esempio è uno che ama l’idea che il jazz diventi la musica classica americana. Ma per fargli acquisire quello status, il jazz perderebbe in freschezza, perché diventerebbe un monumento, una cosa da museo”. Scrivere questo è come affermare che la musica classica è ormai roba da museo… Specialmente in presenza di altri spunti polemici, come l’ironia, nemmeno tanto velata, che descrive il “compositore” come un soggetto dai “capelli cotonati… di solito un po’ sofferente” e dedito alla “cura dei dettagli”, o il passo: “[Elio e Zappa] sono entrambi di provenienza “colta” (ahi! che brutto termine)”. Senza contare che Bollani continua a distinguere i vari generi musicali, avendo però dichiarato avversione nei confronti della loro differenziazione: “I generi sono etichette che provengono da origini esterne alla musica, volute perlopiù dai mass media”. Io non mi sento di accogliere questo modo di pensare. Classica, leggera, liscio, jazz sono distinzioni che raggruppano modi svariati e riconoscibili – per le loro peculiarità – di comporre e proporre musica; sono differenti, ma somigliano, alle classificazioni interne alla musica classica (sinfonica, da camera, operistica) nate non certo dalle esigenze dei mass media, ma in relazione alla maniera e alla destinazione, e accostabili ai generi della Letteratura (prosa, poesia, epica, lirica, drammatica, fino a giungere alle ripartizioni più specifiche, quali romanzo, racconto e simili). Del resto lo stesso Bollani si contraddice clamorosamente arrivando a parlare di “altre musiche” quando, a proposito del jazz, sostiene che ” è un modo di stare insieme, sul palco, di fiducia nelle capacità e nella sensibilità dell’altro, che è difficile riproporre nella vita reale ma anche nelle altre musiche…”.
Anche l’attribuzione a qualcuno di qualcosa che non è proprio suo, sarebbe da evitare: “Persino il rock and roll è nato come una danza: il termine fu inventato da un DJ radiofonico [7] ed è diventato paradigma di un intero mondo, quello dei “giovani” (contro i “matusa”, come direbbe Elio)”. Ma non è Elio che può rivendicare un’espressione che, quanto meno, risale alla vigilia del Sessantotto (1966, per la precisione), usata come abbreviazione di Matusalemme per “etichettare” le persone di qualunque età, ma dalle idee vecchie e superate.
Una sconfortante ingenuità si incontra quando il Bollani prende a criticare l’assenza del “presente” nei testi delle canzoni, con considerazioni che si succedono in modo anche farraginoso: «”Era una casa molto carina, senza soffitto senza cucina” (un testo cantato da Endrigo su una musica di Vinícius de Moraes). Perché è al passato?». Che domanda! L’imperfetto è il tempo delle fantasie infantili e delle favole: c’era una volta… L’autore prosegue: “In Canzone per te [di Sergio Endrigo] si usa il futuro ma per parlare di un presente che si teme già in odore di passato. Lontano lontano di Luigi Tenco ha lo stesso impianto. “Qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ricordare i miei occhi, i miei occhi che ti amavano tanto…” Come nelle opere di Vinícius de Moraes… E il presente dov’è, il presente, in questi poeti impegnati a fare altri progetti, mentre la vita accade?”. Il presente, caro Bollani, è l’impoetico per eccellenza, anche perché dura un frammento infinitesimo. Il presente esclude la fantasia: ciò che è non può essere né elaborato dal ricordo né prefigurato, ma semplicemente vissuto. Il presente ha sostanza inafferrabile, ineffabile. Quello che ho scritto è già passato e quello che sto per scrivere è futuro. Ogni lettera di questo scritto è il brevissimo presente del dito che si posa sulla tastiera. Caro Bollani, ti conviene pensare in musica…!
Ci sono poi imperfezioni più gravi, che riguardano la chiarezza formale ed hanno a che vedere anche con la logica, senza considerare la zoppìa grammaticale. “Si possono prendere gli accordi (cioè l’armonia) di una canzone e usarli per farne una nuova, ma non il contrario, cioè usare una melodia per crearne un’altra, poiché ci condurrebbe dritti all’accusa di plagio”. Il contrario dell’assumere una stessa combinazione di accordi per innestarvi due, o più, differenti melodie, è “prendere” una melodia e armonizzarla in due o più modi, non “usare una melodia per crearne un’altra”! E la sintaxis clauda? Ecco i nessi zoppicanti: “Si possono prendere gli accordi… non il contrario… poiché ci condurrebbe…”.
Da notare infine che non è che la cosa di cui parla Bollani non si “possa” fare: semplicemente non è lecita.
Per le carenze grammaticali ci sono passi eclatanti: “Un altro elemento che possiamo aggiungere alla lista di elementi costitutivi della musica sono quelle che chiamiamo dinamiche”. C’è da essere orgogliosi della concordanza “un altro elemento… sono quelle”… orgogliosi anche dei correttori di bozze della Mondadori! La proposizione relativa “che chiamiamo dinamiche” ha come soggetto sottinteso ‘noi’, complemento oggetto il pronome relativo e predicativo dell’oggetto ‘dinamiche’; la proposizione principale, nel modo in cui è costruita, ha come soggetto ‘un elemento’ e come predicato nominale ‘sono quelle’. Diverso sarebbe stato scrivere: “Quelle che chiamiamo dinamiche sono un altro elemento che possiamo aggiungere…”. In tal caso ‘quelle’ avrebbe funto indubitabilmente da soggetto e ‘un altro elemento’ sarebbe divenuto parte nominale del predicato. Almeno così mi risulta. Perché poi ripetere “elemento… elementi”? La seconda volta non sarebbe stato meglio scrivere ‘delle componenti costitutive’?
Errore simile si riscontra al capoverso “la vera tragedia non sono quei funerali del sud”, anche se in questo caso si potrebbe, con qualche sforzo, accettare come soggetto della frase ‘i funerali’.
Scorrendo più avanti ci si imbatte in un altro pasticcio grammaticale: “Avere gli strumenti per godere della musica non significa conoscere né l’armonia né l’epoca in cui è stata scritta…”. La forma corretta è evidentemente: “non significa conoscere l’armonia o l’epoca in cui è stata scritta”, altrimenti il senso diventa esattamente antitetico a quello che l’autore intende proporre. Bollani ha scritto in pratica che “avere gli strumenti per godere della musica non significa non conoscere l’armonia o l’epoca…”, ovvero per “godere della musica” è necessario conoscere armonia, epoca, ecc. Insomma la doppia negazione in questo caso afferma senza scappatoie.
Nel periodo “Mi chiese quanto tempo avessi suonato, e gli risposi un’ora e mezza” troviamo l’ormai consueta abitudine di scandire le mezze ore con l’aggettivo concordato al femminile, ‘mezza’, anziché, come sarebbe corretto, con il sostantivo ‘mezzo’, metà dell’unità: un’ora e mezzo, le sette e mezzo, dunque, non ‘e mezza’.
Per quanto concerne le concordanze un vero e proprio svarione è il riferimento di due predicati, uno al singolare e uno al plurale, allo stesso soggetto singolare: “È un pubblico che vuole semplicità, ma non nella sostanza di quello che vedono“. Il “pubblico vedono” è una delizia!
Altro passo difettoso è “Gli Improvvisi di Schubert o le Improvvisazioni di Poulenac… venivano fissate su carta”: ‘fissati’, forse, visto che il participio si riferisce contemporaneamente a due termini, di cui uno maschile, genere che nella concordanza prevale sempre.
Anche servirsi dell’aggettivo dimostrativo “questo” in luogo dell’articolo indeterminativo è una sgrammaticatura quando si allude a qualcuno che non si è nominato: “Una volta ho visto il clarinettista che suona con me nel gruppo I Visionari, perdere la pazienza. C’era questo sassofonista francese, indossava un cappellino…”. Questo chi? Bollani introduce lo strumentista non avendolo presentato né avendone prima parlato, dunque “c’era un”, senza alternative.
Poco più in là si rinviene un lapsus (che è anche un cattivo impiego del tempo verbale) alquanto ridicolo: “Sento i suoi dischi da quando sono bambino“. A parte che i dischi si “sentono”, quindi si odono, se il loro suono giunge da lontano (mi pare di sentire un disco…), e dunque si doveva scrivere “ascolto”, viene da pensare che il musicista continui da sempre… ad essere bambino! Diamine: si può sbagliare parlando, ma scrivendo… Il presente che segue ‘da quando’, indica un permanere nella condizione indicata, l’essere bambino, cioè, che logicamente in questo caso non è plausibile: “da quando ero bambino”, perciò. Immaginate un ottantenne che vi dica che fa una certa cosa da quando è giovane!
Ancora la grammatica: “C’è una linea sotterranea che unisce la musica che [Eicher] produce, dal jazz norvegese di Ian Garbarek all’Argentina di Dino Saluzzi o il Brasile di Alberto Gismonti”. Dal jazz… all’Argentina… al Brasile, non “il Brasile”!
Si può leggere pure che Bollani “va in caccia”, invece che “a caccia” della trovata; oppure che “là in mezzo, fra questi due paletti, c’è una terra da esplorare”, mentre si sarebbe dovuto scrivere “là… fra quei”, come “qui, fra questi”.
Si scorra adesso con attenzione il periodo che segue: “Gli piacevano i Beatles [si parla di Eric Dolphy], eppure li prendeva di mira. Nel già citato Sgt. Pepper’s c’era un po’ di tutto: l’orchestra sinfonica, il minimalismo, il sitar indiano, mancava solo il jazz. Il risultato è un capolavoro perché ebbero l’intelligenza…”. Qual è il soggetto di ebbero? L’intelligenza capisce, con un po’ di adattamento, ma la grammatica… è a passeggio…
In un altro punto del libro si incontra: “Mi sottraggo da tutta una serie di esperienze possibili”. “Sottrarre da” è più un trafugare; per indicare il rinunciare a, il privarsi di, l’eludere, la preposizione da usare è “a”, “mi sottraggo a”.
Sicuramente errore grave è apporre l’articolo indeterminativo, come fa Bollani, a un nome che ha solo il plurale, pretendendo che diventi singolare: “un mass media”! Come scrivere “un pantaloni”.
Il controllo dei tempi verbali non è sempre da imitare. Si legga questo trapassato prossimo seguito dal passato prossimo anziché da un più corretto trapassato prossimo: “L’opera di questi ragazzi era stata scoperta da un critico d’arte il quale poi li ha invitati alla Biennale di Venezia perché allestissero là la loro piccola favela”. Io avrei scritto “li aveva invitati”. Bellissima, per inciso, anche l’allitterazione “allestissero là la”…! Un’eufonia da grande orecchio musicale (per la lingua), come si riscontra anche nell’espressione: “Durante il concerto a un certo punto” [8]. Anche la relazione fra il passato remoto, l’imperfetto e il passato prossimo, nel capoverso successivo, è da prosa manzoniana… “Dunque i ragazzi del Morrinho trascorsero due-tre mesi (credo di ricordare) a Venezia, dove, mi riferiva il mio accompagnatore, hanno tentato di giocare a pallone in tutti gli angoli”.
Altra dimostrazione di “padronanza grammaticale”: “Un marziano a Roma, una commedia di Ennio Flaiano con Vittorio Gassman, non era andata per niente bene a Milano, e lui, tornando a Roma, disse…”Lui chi? Si suppone Gassman, ma l’uso del pronome claudica… Avrei preferito “e l’attore, tornando a Roma…”. Troppo difficile?
Qua e là si riscontra un uso “poco opportuno” del linguaggio informale. Ad esempio in “grandissima astuzia ripresa paro paro“: davvero di cattivo gusto far ricorso a una così brutta espressione, popolare e antiquata! Ma ci sono casi anche più grossolani… Come: “La vera tragedia presuppone due palle così“, oppure: “Mengelberg ha un umorismo tutto suo e, come per altri grandi freak, non sai se ti sta coglionando o consegnando una perla di saggezza” (detto fra parentesi, dopo un verbo di dubbio è richiesto il congiuntivo: “non sai se ti stia”). Altra eleganza: «Per inciso, il salomonico Enrico Rava dice: “I referendum sono una stronzata, ma già che esistono conviene vincerli”», cui fa eco la citazione dello stesso tenore: «Un guru degli anni Settanta come Tom Robbins diceva giustamente: “Il solo motivo per cui Dio ci tollera è il nostro talento per le stronzate“». La vetta (o il fondo) è comunque nel capitolo 22°, dove si può godere: “La musica, come il teatro, non è in mano solo al regista, e se c’è una diva alla quale tutti devono stare attenti per intercettare i suoi cambi di umore tutto diventa più difficile. Diventa un’accolita di persone che fanno di tutto per mettere a proprio agio il protagonista, il signor Stocazzo“; non poteva mancare, ovvio, la “scossa di assestamento” nel capitolo successivo: “e la volta che metto il piede su un’ortica dico: “Ah, ma che posto di merda!”.
Voglio ascrivere a questa categoria dell’informale, per dir così, anche il brutto intercalare “okay”, prendendo atto che la nostra bellissima “lingua del sì” è diventata la “brutta lingua dell’okay”!
Fra le argomentazioni che non convincono (per non dire sballate) c’è quella con cui si cerca di spiegare che la scrittura musicale può risultare ingannevole e che non sarà mai possibile “eseguire la partitura come vorrebbe Mozart”: “Prendete le pause nelle battute di Romeo e Giulietta: chi ti dice quanto devono durare? Non Shakespeare. E comunque il tempo di oggi non può essere lo stesso di allora…”. Nessun drammaturgo ha mai dato indicazioni del genere: la scrittura per teatro non può essere paragonata allo spartito musicale, dove peraltro la durata di un suono o di un silenzio non è segnalata in secondi, ma in frazioni matematiche (2/4 1/8 1/32) che vanno rapportate alla velocità (o andamento) indicata genericamente da un allegro, un presto, un andante, i quali possono essere assoggettati al gusto o all’istanza filologica dell’interprete (lo stesso metronomo ha gamme di tolleranza per ogni “tempo”, suggerendo valori variabili: presto 168-208, andante 76-108, adagio 66-76, ecc.), né sempre le partiture hanno prescrizioni perentorie a riguardo (del tipo 1/4=120 [9], che impone un preciso passo moderato); ma si rischia di scivolare in nozioni troppo specifiche. La scrittura teatrale si presta sicuramente ad una maggiore flessibilità interpretativa ed ha il suo valore soprattutto in quanto letteratura, che chiunque sia dotato di un buon grado di cultura può leggere e gustare nel segreto della sua stanza. La musica va suonata: pochissimi sono in grado di “udirla” attraverso lo spartito silenzioso. Ritengo perciò improprio l’accostamento che fa il Bollani. Per quanto riguarda l’epoca è evidente che le sensibilità mutano, ma un adagio non diventerà mai un allegro.
Altrettanto inadeguato mi sembra l’accostamento al Goldoni, sempre in margine al problema della fedeltà dell’interpretazione musicale in rapporto alla scrittura del compositore: “Igor Stravinskij ha interpretato e inciso di persona le sue creazioni. Di fronte a quel disco cosa si fa? Sarebbe come se avessimo una registrazione di Carlo Goldoni che recita La bottega del caffè. Solleverebbe alcune difficoltà, credo. Ha ragione lui, dunque? Insomma: no. Hanno ragione anche gli altri”. Ancora il parallelo fra Musica e Letteratura, qui più tollerabile, ma pur sempre inidoneo.
Criticando il fatto di considerare perfino la “musica commerciale” come genere, Bollani scrive: “Anche la Quinta di Beethoven viene pubblicata su disco e venduta”, volendo significare che tutta la musica andrebbe considerata allora commerciale. Il fatto è che in effetti, sia pure non come genere, la musica commerciale esiste davvero, ed è a mio avviso tutta quella produzione scadente che viene concepita per la vendita di massa, una massa “poco educata” al bello e in possesso di un gusto facile e deteriore indotto dal mercato stesso, per un più agevole consumo. Beethoven non scrisse certo le sue sinfonie spinto dal criterio dello smercio, ma, suppongo, convinto di creare quell’opera d’arte che esse sono.
Argomentazione molto fiacca è anche la seguente: “E ‘musica d’ascolto’ invece cosa vuol dire? Ahi, orrore! [...] ‘Scusa, tu fai musica d’ascolto?’ E che domanda è? Presuppone che tutta l’altra musica vada fatta passare non dalle orecchie ma dal naso? O dalla bocca?”. Non si possono ignorare così banalmente certe dinamiche del sistema. Le denominazioni nascondono sempre una verità, e attraverso quelle verità si giustificano. Non si tratta di godere la musica con il naso o con la bocca: un “letterato” dovrebbe sapere che esiste il linguaggio figurato… all’espressione “musica di ascolto” manca l’attributo “facile” che qualifichi l’ascolto, tutto qui. Essa nasconde la scarsa considerazione per il fruitore e la pochezza di certi “musicisti”.
Un accostamento assai improprio si trova all’inizio del capitolo 18°: “Non amo il termine ‘contaminazione’ perché – come dice Paolo Fresu – sa di ospedale”. Questa battuta, che il Bollani fa propria, sa di poca dottrina. La “contaminatio” non è un contagio, ma una tecnica. In fondo il jazz si basa proprio su criteri di aggiunta, di sottrazione, di variazione, di estensione, di incontro di generi, di contaminatio, appunto…; nonostante l’autore ribadisca subito dopo la sua ingiustificata idiosincrasia per la varietà delle maniere musicali: “Non amo definire questo e quello in termini di generi musicali”, e aggiunga, disarmando: “In altre parole, si può anche parlare di rock, di reggae, di ritmica latina, di accompagnamento jazz, di ‘tiro’ funky, ma poi si dovrebbe ascoltare la musica”. Non vedo come la distinzione in generi possa compromettere la possibilità o la capacità di “ascoltare la musica”! L’argomentazione sconcertante non si ferma qui e vale la pena di leggerla tutta: “Perché spesso, parlandone, si descrivono dettagli in maniera peregrina; cioè se io dicessi che Debussy usa degli ‘accordi di quarta’ e compone pensando a scale musicali orientali, direi il vero, okay. E potremmo parlare di orchestrazione, di concatenazione degli accordi, di sviluppo del tema e via dicendo. Ma sono termini tecnici, che il lettore medio non riesce ovviamente a padroneggiare. E allora ci si lancia a dire che Debussy usa sonorità liquide o che “il suo legame con il simbolismo di Mallarmé” o che “la sua francesità fin de siècle” e blablabla tutto bello e a volte pure poetico ma tutto riguardante le cose INTORNO alla musica, non la musica in sé”. Che ovvietà, che confusione (e che forma sciatta)! Sarebbe come avversare l’analisi della struttura prosodica e metrica di un componimento del Foscolo richiamando il lettore alla “poesia in sé”. Tutto sommato il Bollani dichiara in tal modo, in maniera clamorosa, l’inutilità (o la nocività, addirittura) del suo libro… che non è certo “la musica in sé”, concludendo che “più parliamo di musica più ci allontaniamo dalla cosa in sé” e forse non rendendosi conto che un fatto del genere avviene sempre, non solo per la musica. Perfino se parlo di una persona, mi allontano dalla persona in sé!
Poi il pianista se la prende (diciamo così) con il Romanticismo: “…e dunque tutti noi quando parliamo di musica siamo dentro ad altre categorie, parliamo per colori oppure per sensazioni, emozioni… ‘questa musica così romantica…’. Ma cos’è il Romanticismo? Dovrebbe essere una corrente ben precisa, dovrebbero essere Chopin e Liszt, invece vien fuori – per estensione, ma accidenti che estensione! – che se ci commuoviamo di fronte a un tramonto, o se qualcuno dice: “Ti amo”, o se regaliamo un fiore, siamo romantici. «Le parole sono importanti» diceva Nanni Moretti…” A parte il “genio” del Moretti per una considerazione così profonda, per un concetto vecchio quanto la parola, mi pare proprio che il Bollani ignori ancora una volta la polisemia e non distingua il romanticismo psicologico, ideale, universale, dalla corrente storica che rivestì il vocabolo (già presente in Inghilterra nel Seicento) della sua definitiva connotazione e che fondò la sua poetica sulle caratteristiche generali riferibili a quella propensione esistenziale più orientata “alle suggestioni del sentimento e della fantasia che ad una concezione razionale e pratica” (Treccani), vocazione che non ha tempo e che appartiene alla natura stessa dell’uomo! Dia magari uno sguardo all’etimologia del termine, il caro Bollani, che ha commesso l’errore di aver considerato solo la parola con la lettera maiuscola… [10]
Passando ad altra argomentazione si legge nel capitolo 22°: “Il cantante deve avere un grande controllo del suo strumento, la voce, e contemporaneamente ascoltare gli altri. Provate voi a parlare e intanto ascoltare quel che dice un altro”. Le parole di due che parlano, mai potranno fondersi, come avviene, invece, per i suoni. Due che parlano contemporaneamente non sono ammessi, dieci che suonano simultaneamente, sì, purché eseguano lo stesso brano. In questo caso l’ascolto è possibile, al punto che l’esecuzione dell’uno può essere condizionata da quella dell’altro e viceversa. Batteristi diversi, ad esempio, possono indurre un tastierista a creare in modo differente; e questo, evidentemente, non senza ascolto. Il rilievo del Bollani risulterà ancor più inappropriato una pagina avanti, quando si legge: “La musica è invece l’arte dell’ascolto. Ascoltare e parlare e insieme sentire quello che accade attorno”; e si chiosa: “Certo, si guida e ci si lascia guidare, a turno”.
Gli ultimi capitoli del libro mi sono sembrati solo intitolati e non trattati: ai titoli non corrisponde infatti uno “svolgimento condotto in forma sistematica” (Devoto). Il 19°, ad esempio, s’intitola “E parlare di cultura?”, con riferimento all’intestazione del 18° che è “Si può parlare di musica”? Chiunque legga le tre facciate che compongono la sezione non troverà certo la risposta all’interrogativo! La serata di Umbria Jazz, il palco in una favela, uomini che sparano contro le macchine della polizia, il giro che l’autore fa nella favela il giorno che precede il concerto, la visita alla favela in miniatura, le terme per i massaggi ed “altro”, i ragazzi del Morrinho che giocano a pallone in tutti gli angoli di Venezia, le considerazioni dell’accompagnatore di Bollani, un ragazzo che non si rende conto del perché il “gioco” che ha fatto per tanto tempo (il plastico) sia considerato “arte” (cosa che rischia di togliergli il divertimento) e riflessioni dello “scrittore” che avverte di aver applicato al suo fare musica l’insegnamento del ragazzo… Un bel minestrone. Allora, si può fare cultura? Chi dovesse capire qualche cosa me la spieghi: gliene sarò grato.
Per buona sorte il libro è finito, ma l’autore fa in tempo a trarre qualche acuta conclusione sulla musica. “È un peccato, voglio dire, che ci si fermi al: “mi ha emozionato”/“non mi ha emozionato”, come su facebook”… Evidentemente egli non conosce la natura del gregge, la massa del pubblico che “decreta” il successo, in ogni campo, e sembra non aver proprio compreso che l’emozione è lo stupido parametro di valutazione oggi in voga, se spera che la gente lasci da parte “il birignao del sentimento”. Folla che non capisce niente, ma, se si emoziona, crede di aver capito tutto e avalla anche l’arte che non c’è. Per fortuna Bollani, per eccezione, merita il successo che riscuote come pianista jazz, indipendentemente dalla capacità che il pubblico ha di capirlo.
Peccato che abbia assenze e lacune di pensiero… Scrive ad esempio che “fino alla fine dell’Ottocento nessuno ascoltava la musica del passato”. Se tralasciamo il fatto che nemmeno tra i musicisti c’era l’abitudine di frequentare un repertorio che prevedesse di riproporre musica delle epoche precedenti, come sarebbe stato mai possibile, prima dell’invenzione della radio, sedersi “in poltrona per ascoltare musica”?
Lascia che io ascolti la tua bella musica abbandonato sulla mia sedia, caro Stefano, e prima di scrivere un altro libro, pensaci sei volte!
Dimenticavo: perché “table of contents” invece del semplice e bellissimo “indice”, alla fine di uno scritto pubblicato per gl’Italiani?
Mi consolo con il buon Plinio il Vecchio: “Non c’è libro tanto cattivo che in qualche sua parte non possa giovare”.
Amato Maria Bernabei
[1] Il giudizio appare quanto meno strano, soprattutto in rapporto alle complicatissime strutture della musica indiana, variabili in relazione al ciclo delle stagioni (cinque), al ciclo giornaliero suddiviso in otto fasce della durata di tre ore ciascuna, al ciclo ritmico, in cui si distinguono una frazione introduttiva (detta Alap, che consiste in un’improvvisazione aritmica), cui segue la sezione accompagnata dai tabla, strumenti a percussione; il tala “rappresenta il modello ritmico a carattere ciclico all’interno del quale si sviluppa l’intera struttura musicale. Tale ciclo ritmico può essere configurato in differenti forme metriche, quali ad esempio, nel sistema Hindustani del Nord India, il Tin Tal (in 16 misure), il Jhap Tal (10 misure), il Rupak Tal (7 misure)”. Non esistono le suddivisioni occidentali in quarti, ottavi e simili, ma caratteristiche e non semplici impianti ciclici, i quali si combinano con la forma del raga e vincolano l’improvvisazione.
Quella indiana è una musica modale molto complessa, raffinata ed espressiva, che si fonda sul Raga, che “in estrema sintesi, è un modo, ovvero una scala musicale, dove le note sono selezionate e poste in posizione gerarchica fra loro. All’interno della scala vengono definiti alcuni passaggi obbligati” nella sequenza delle note stesse, “la successione delle quali non è quindi sempre lineare”. http://www.artemusa.it/musica_indiana.html Va detto che le scale previste sono innumerevoli.
[2] Negherà infatti che l’accordo minore sia legato al sentimento della tristezza e quello maggiore al sentimento dell’allegria.
[3] Jean Cohen, Struttura del linguaggio poetico, Il Mulino, Bologna.
[4] http://www.blitzquotidiano.it/video/marina-chapman-bambina-allevata-dalle-scimmie-1525078/
[5] Fabrizio Pirovano, La comunicazione persuasiva, De Vecchi Editore 2001, p. 36.
[6] Unità di misura della frequenza dei fenomeni periodici; un fenomeno ha frequenza 1 hertz se un suo periodo dura 1 secondo; simbolo Hz (Devoto).
[7] Alan Freed, che nel 1952 tenne quello che viene considerato il primo concerto rock http://rockciclopedia.com/wiki/index.php?title=Rock_and_Roll
[8] Capitolo 23°.
[9] La notazione indica una velocità in cui dovrebbero essere eseguite due semiminime al secondo, 4/4 in due secondi, 120 semiminime in un minuto.
[10] Il termine “romanticismo” designa “ogni atteggiamento o aspetto connesso alle suggestioni e alle aspirazioni vaghe del sentimento, alle commozioni e agli incanti della fantasia” (Devoto). Catullo era certamente un romantico, pur precedendo di circa diciannove secoli il movimento dello sturm und drang. Per quanto concerne l’etimologia della parola, si possono trovare alcune indicazioni anche al link http://luoghi-manzoniani.jimdo.com/alessandro-manzoni/romanticismo/

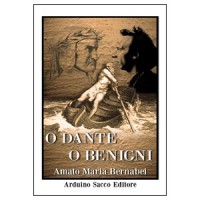
*

To prove that you're not a bot, enter this code