Che garanzie di qualità può offrire chi vanta di aver passeggiato
con il Nobel russo Iosif Brodskij “nelle CALLE” [1] di Venezia?
ascolta
Epilogo
Tutta la notte la sognai gridando,
piangendo dentro il più angoscioso sogno.
Era lei, Caterina, l’infelice
“regina delle Streghe”? La rividi,
macilenta bambina che danzava
con gli occhi fissi a un cupo sortilegio,
presso il bosco di casa, sotto i rami
pagani della “quercia delle fate”.
Lei, quella buia figlia di regina,
si era arrogata un titolo fatale.
Dov’era andata? Quali conciliaboli
l’avevano irretita e poi perduta?
«Io mi assumo la croce» avevo detto
la notte degli addii. Non sapevo
che la sorte tramasse di assegnarle
il tormento a me sola destinato.
Passai tre mesi inerti, pullulanti
di fantasmi e di miasmi del passato.
Non speravo l’ausilio dell’Arcangelo:
luce alimenta luce, la suprema
Vita disdegna le anime già morte.
Eppure Dio non lascia chi lo spera
con contrizione per la sua salvezza.
E dal profondo io la invoco, Dio.
Guardavo sempre il fuoco nelle sere
di primavera e della prima estate.
Lo fissavo per ore. A lui chiedevo
direzione, consiglio, ispirazione.
Giunsero giorni di caldo scirocco.
Giallo era il cielo, come un appestato.
Si era fatto, il vallone di Jaulny,
un forno arroventato senza pane.
Il vento scardinava i tetti, i sassi,
bruciava i bocci e dissecava i frutti.
Laggiù al fondo dei pozzi rilucevano
poche lacrime di polvere e mota.
Venti giorni senz’aria respirabile.
Morivano gli armenti. Un malefizio
premeva sulle case addormentate
come quanto [2] un cristiano è insepolto.
Forse insepolto era il mio passato
mozzo, irredento un Cristo non risorto.
Mi aggiravo sperduta fra i saloni,
disperata chiedendo una risposta.
Nel gran silenzio soltanto una fiamma
gridava dal camino di cucina
che risucchiava tutte le scintille
in alto fuggitive sfrigolando.
Il guardiaboschi [3] si fece annunciare
e concitato disse che ad oriente
del castello una striscia molto estesa,
un miglio forse, aveva preso fuoco.
Tutte le grandi querce millenarie
erano pura cenere. Ordinassi
che allarme dare, che cosa decidere.
Sotto quel rozzo panno era la Voce?
Sì, era il Segno, Dio mi rispondeva.
Come a un amato a lungo a lungo atteso
mi avviai nel buio incontro al fuoco. spire
color di sangue e aurora mi ammantarono,
timide prima, e poi ruggenti e forti,
ben diverse dal fuoco stupratore
che su quel rogo mi avrebbe avvinghiata.
Profondo abbraccio, appassionato e unico.
E mentre già le vesti fiammeggiavano,
di colpo Lui mi apparve: era l’Arcangelo
del nostro primo incontro, e il mio stupore
rinacque intatto dai lillà di casa.
«Tu chiamavi piumaggio queste luci
che alle spalle mi spuntano, Giovanna.
Devi sapere: sono pura fiamma
e in cima al tuo destino ti aspettavano».
(da https://poetarumsilva.com/2018/03/04/spaziani-epilogo-giovanna-darco/)
_______________
[1] Le calle sono fiori, mentre le strette vie di Venezia sono le calli!
[2] Nel volume pubblicato dalla Marsilio (2000) si legge correttamente “quando”. Chi in Internet pubblica materia letteraria dovrebbe sorvegliare perlomeno l’ortografia…
[3] “Guardiaboschi”? Refuso (presente nell’edizione della Marsilio del 2000) o granchio lessicale della “poeta”?
____________________________
INTUIRE DAL TRAMONTO
 Leggendo l’Epilogo della Giovanna D’Arco di Maria Luisa Spaziani viene da pensare che un fosco tramonto è spesso l’esito di un trascorso cattivo giorno!
Leggendo l’Epilogo della Giovanna D’Arco di Maria Luisa Spaziani viene da pensare che un fosco tramonto è spesso l’esito di un trascorso cattivo giorno!
Non ho mai avuto il desiderio di conoscere il capolavoro della poetessa torinese (la poeta, se in memoria non vogliamo offen-derne la suscettibilità femminista [1], la quale, tuttavia, in un passo della postfazione alla “Giovanna d’Arco”, a pagina 94 dell’edizione 2000 della Marsilio, non disdegna di attribuirsi la “privilegiata situazione di libero studioso”, con due belle desinenze maschili!), voce dalla quale non mi sono sentito mai attratto, non sembrandomi abbastanza interessante né tanto meno grande, checché se ne dica, e quando mi sono imbattuto in questo passo di modesta letteratura non me ne sono certo pentito. Non esercito la professione del critico, ma sono convinto di aver maturato conoscenze e sensibilità adeguate per individuare la buona letteratura. Difficilmente ho letto una chiusa “letteraria” così brutta, spia di un fiacco gusto estetico, di un pensiero ordinario, di una padronanza metrica approssimativa, di una carente sensibilità musicale capace di trasformare un passo cadenzato e grandioso come quello dell’endecasillabo nella più comune delle prose, per di più in un contesto epico. Leggo, della Giovanna D’Arco, che è un poemetto in ottave. Sul sito della Marsilio è scritto nientemeno che «Maria Luisa Spaziani, fa rivivere Giovanna d’Arco e la inquadra nella musica delle sue ottave classiche». Da quando in qua l’ottava (classica, per di più) è diventata un capriccioso raggruppamento di otto endecasillabi senza rime, di cui non si conosce il criterio compositivo se non quello che appone il punto dopo l’ottavo verso e ricomincia la sequenza lasciando una riga vuota? Quelli della Spaziani sono nient’altro che brutti endecasillabi sciolti (non sempre “endeca”), senza nervo, artificiosamente separati in gruppi di otto. L’endecasillabo non è soltanto una sequenza di undici sillabe metriche contate magari sulla punta del naso, qualche volta anche male [2], come nel caso di “rustica, dall’unico spiovente” Canto I, pag. 9, che è un decasillabo non canonico [3], o di «a distesa trecento campane» e «accadrà nella valle di Jòsafat» del Canto IV, pag. 47, decasillabi canonici, il secondo sdrucciolo, o «radice prima. Mi fecero abiurare», verso di dodici sillabe metriche (con sinalefe “ro a”) non canonico, del Canto V, pag. 62, e il decasillabo canonico “fissamente da presso la morte”, Canto V pag. 65, e così via… [4]: l’endecasillabo è un suono, un segmento di suono che unendosi agli altri segmenti deve creare una melodia varia, flessibile, in grado di adattarsi al pensiero (possibilmente PENSIERO) che esprime, come la mimica di un volto è modellata da uno stato d’animo. Così Dante dipinge (Dolce color d’orïental zaffiro), rimpiange (Siede la terra dove nata fui), prega (Vergine madre, figlia del tuo figlio), lotta ed ansima (E come quei che con lena affannata), paventa (ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi), descrive (Come d’autunno si levan le foglie), consiglia (Ond’io per lo tuo me’ penso e discerno), sentenzia (Amor, ch’a nullo amato amar perdona), inveisce (Ahi serva Italia, di dolore ostello), ama (la bocca mi basciò tutto tremante), enuncia principi universali (fatti non foste a viver come bruti), attinge filosofia e teologia (La gloria di colui che tutto move; Quella circulazion che sì concetta)… Si potrebbe continuare per pagine, dimostrando come all’interno di una misura costante possano trovare spazio i più disparati pensieri e i sentimenti più vari attraverso le più sottili sfumature, gli spunti più impensati, sempre congrui nelle loro dimensioni concettuale e sonora [5], fuse in armonia suprema.
Gli “endecasillabucci” della Spaziani (“una delle voci più autorevoli e suggestive della poesia contemporanea”, è scritto nella bandella posteriore del volumetto) arrossiscono. A dimostrarlo basta riportare la banalità di due versi che “epicamente” dovrebbero farci rivivere le fiamme del rogo patito da Giovanna D’Arco: ben diverse dal fuoco stupratore / che su quel rogo mi avrebbe avvinghiata… Brutta enfasi a parte, una “prosetta” divisa in sillabe, che peraltro caratterizza tutto l’Epilogo e, sospetto, l’intero poemetto… [6]
Inutile infierire, per ora, non disponendo ancora dei necessari elementi per approfondire.
La fama e la stima di cui la poeta torinese gode non sono, evidentemente, che prodotti del mercato, teso a creare i suoi miti da bancarella su parametri ben distanti da quelli che il valore esige, in ogni campo. Chi per qualunque motivo abbia visibilità e sia per questo vendibile, sale i gradini delle gerarchie.
Di conseguenza la Spaziani è grande… ma soprattutto nella fortuna di essere piaciuta a Montale, il quale, non a caso, l’appellò con il nome fittizio di Volpe [7] dal “lieve / zampetto di predace” [8].
(Che cosa piacque a Montale della Spaziani? De gustibus non est disputandum…
ma il bello non è quasi mai ciò che piace, come il vero non è quasi mai ciò che si pensa)
Amato Maria Bernabei
[1] “…è doveroso chiamarla così, poiché detestava la definizione di poetessa che le sembrava maschilista ed escludente” (Franca Alaimo, Lieto Colle, Libriccini da collezione, 7 aprile 2015, in https://www.lietocolle.com/2015/04/silvio-raffo-la-divina-differenza-la-musa-lirica-di-maria-luisa-spaziani/). Sciocca suscettibilità! Saffo non si sarebbe mai offesa, forse perché era “poetessa” vera… Sciocca, soprattutto, perché, nel rinunciare pretestuosamente al sostantivo femminile, tanto vicino per suono al termine greco ποιητής (poiētḗs), la Spaziani fa uso, paradossalmente, del sostantivo maschile, femminilizzato dall’articolo, attribuendogli di fatto maggior valore e contraddicendo all’intenzione di garantire alla femminilità della sua arte una considerazione pari a quella riservata agli uomini. Per celia si può osservare che Montale non si è proprio mai preoccupato della a finale della parola poeta, altrimenti si sarebbe ribellato, pretendendo l’appellativo di “poeto”…
[2] Accortasi della presenza di alcuni decasillabi, la Spaziani preciserà nella postfazione, che «L’orecchio coglierà subito l’inserto di qualche decasillabo dovuto a precise ragioni espressive». La “poeta” adduce una serie di giustificazioni documentate da riferimenti a versi precisi, senza riuscire ad essere convincente. Una sciocchezza sembra soprattutto la dichiarazione di aver voluto rallentare il ritmo della versificazione con l’inserimento (non l’inserto, che ci pare altra cosa…) di un verso incalzante come il decasillabo canonico (tatatà tatatà tatatà ta), che la sapienza e la musicalità manzoniane avevano collegato allo scalpitio dei cavalli: d’ambo i lati calpesto rimbomba / da cavalli e da fanti il terren (Alessandro Manzoni, Il Conte di Carmagnola, Atto II, Scena VI, vv. 3-4). Ad esempio: come può suggerire «l’idea della pigrizia e della noia del re» la cadenza anapestica del decasillabo riposarmi dai lunghi travagli? Se scrivo “quando tento un tranquillo riposo”, il decasillabo può suggerire magari il fallimento del tentativo per uno stato di eccitazione inibente, non di certo la pigrizia, la noia, l’abbandono!
[3] Quale “precisa ragione espressiva” avrà indotto la poeta all’uso così precoce di un decasillabo in «un’ottava classica»? (Maria Luisa Spaziani, Giovanna d’Arco, Venezia, Marsilio, 2000, p. 105).
[4] Incuriosito (negativamente) dalla lettura dell’Epilogo, ho acquistato in Rete al più basso prezzo possibile il poemetto. Alla prima sbirciata ho avuto conferma della pessima impressione avuta in precedenza ed ho potuto estrapolare senza fatica, a caso, i versi riportati.
[5] Livello semantico e fonico, direbbe un addetto ai lavori.
[6] Il sospetto si è poi rivelato fondato.
[7] Senhal che Montale attribuì alla Spaziani.
[8] Montale, Da un lago svizzero, in La bufera, Madrigali privati (il componimento è un acrostico, in cui le iniziali dei versi formano il nome e il cognome della poetessa: omaggio-trastullo di momenti infantili del sentimento, ai quali è difficile riuscire a sottrarsi…).
___________________________
IL DEMERITO DEL MERITO
(ovvero stroncatura di una Musa “a brutto muso”)
La lettura casuale dell’Epilogo del “romanzo popolare” della Spaziani, avvenuta in un sito poco ospitale e poco democratico della Rete, in cui l’uso di un ironico pseudonimo a firma di una mia nota critica severa è divenuto, per anonimato, pretesto di non pubblicazione, mi ha sconcertato al punto che, dopo aver scritto le prime impressioni, riportate come introduzione, ho deciso che dovevo basare le mie critiche sulla conoscenza. A tale scopo ho sùbito controllato le offerte in Internet ed ho speso il patrimonio di ben 7,15 Euro (tutto è relativo, dicono) per acquistarlo. Testo peggiore di quanto mi aspettassi!
Ormai è cosa lampante: la metamorfosi del merito ha il volto di una moneta, il pregio è una distinzione commerciale. Conta soprattutto qualunque ragione che venda, perché ogni valutazione di qualità trova i suoi fondamenti nel mercato. Il successo, in termini di visibilità, di stima, di riconoscimenti, è assicurato a tutto ciò che genera profitto materiale, e si fonda, perciò ed ormai, «sull’incompetenza a tutti i livelli» [1].
La critica sapiente ed illuminata “giace”, anche in virtù di un relativismo che ridà spazio al criterio dei sofisti, capaci di flettere le architetture del pensiero alle esigenze di chi di volta in volta li sfamava. Le attribuzioni di buona qualità e il maggior numero dei giudizi estetici favorevoli sono servi untuosi e supini del tornaconto, sia di chi li proclama che di chi li smercia, sicché gli operatori culturali, nel senso più ampio della parola, sono agenti di spaccio, più adatti al mestiere quanto meno conoscitori della materia specifica e quanto più scaltri nel cogliere le occasioni che rimpinguino le borse, a scapito delle virtù dei prodotti e della possibilità (nociva per il negozio) che la plebe acquirente èlevi [2], sia pure di qualche gradino, il proprio livello di conoscenza.
Il merito legittimo è dunque diventato un demerito, perché troppo spesso non si accompagna alle caratteristiche rivendicate dal commercio, e langue, ignorato e disincentivato. «Non le sto dicendo che la sua opera non merita, ma che non vende», mi disse Cesare De Michelis per giustificare il suo dissenso di fronte al mio poema in terzine dantesche sulla mitologia greca [3], che finì per pubblicare solo dietro richiesta di una cifra esosa e per la diffusione del quale mai spese un centesimo, snobbandone anche la presentazione nella Sala delle Colonne di Montecitorio. Lo stesso De Michelis del quale la pagina ufficiale della Marsilio riporta, con giusto orgoglio, l’aforisma: “È più importante vendere i libri che si fanno che fare i libri che si vendono”. Lo stesso De Michelis che – si dice – aveva firmato assegno in bianco alla Tamaro per un romanzetto sentimentale che, a detta di qualche lettore che conosco, ha poco da invidiare al libro Cuore (parola non casualmente presente anche nel titolo del romanzo della scrittrice triestina), se non la migliore qualità letteraria [4]. Il buon Cesare (peraltro figura di rilievo del mondo editoriale ed accademico dell’ultimo mezzo secolo) che alla firma del contratto, in camera caritatis, riconobbe al poema grande qualità, dichiarandosi orgoglioso di poterlo avere in catalogo e non escludendo che potesse essergli riservata, magari a distanza di qualche decennio, una sorte rilevante, aveva ragione, perché la Tamaro avrebbe venduto sedici milioni di copie in tutto il mondo (Wikipedia) e il mio poema in terzine una decina di copie in Italia. Eppure Giorgio Bàrberi Squarotti, dopo aver “preteso” una copia del libro, chiedendo, quasi risentito, come potesse non saperne nulla, ed avergli dedicato una lettura di alcuni mesi, ebbe a scrivermi, tra il Dicembre del 2007 e il Gennaio del 2008: «La grandiosità di Mythos non ha pari […] è un premio a se stessi incontrare un’opera come la Sua». Parole che, credo, mai nessuno potrà vergare a proposito del romanzo della Tamaro.
Il merito genuino è dunque diventato un demerito.
Al contrario, ciò che non merita viene spesso accolto da grida di osanna e rami di palma, ricompensato da invadente visibilità mediatica, quando non da titoli accademici anche numerosi e paradossali: sia sufficiente citare l’affare milionario del Tuttodante di un ridicolo “esegeta” (se non addirittura “profeta”) dei nostri tempi.
Anche il caso del poemetto della torinese “Musa di Montale” rientra nella categoria incomprensibile (si legga come sinonimo di inammissibile, perché la comprensione del fenomeno è fin troppo scontata) dei successi e delle acclamazioni della mediocrità: è difficile negare che viviamo una stagione capace di inneggiare soprattutto al dozzinale.
Qualcuno, in difesa della “volpe” [5], dirà che “la poeta” (declinazione, questa sì, di fondamentale importanza per l’ipocrita moda che avversa il cosiddetto sessismo linguistico) non aveva intenzione di scrivere un’opera di poesia, ma un romanzo ritmico, una prosa cadenzata… Ai grandi non servono espedienti: la prosa del Manzoni (non si offenda Alessandro, scuotendo la tomba per l’accostamento) è di gran lunga più musicale del brodetto della Pulzella della signora Maria Luisa, al punto che questo viene annientato da qualunque passo, rilevato a caso, del grande milanese, anche evitando di scegliere i vertici di un decasillabo che piange in singulti segreti nel suo ritmo anapestico (Addio monti sorgenti dall’acque, decasillabo con sineresi in di-o, ma anche endecasillabo 4-7-10, se si preferisce, con suddivisione ad-di-o) o di un pittorico endecasillabo descrittivo, dolente di richiamo natio (come branchi di pecore pascenti) o di un endecasillabo dove l’accento di settima comprime la parola nella stretta di un’emozione d’amore (dove il sospiro segreto del cuore).
Gli endecasillabi del “romanzo” della Spaziani mancano di eleganza metrica e prosodica, difettano di vera musica, sono sciatte sillabazioni, talvolta monche o sovrabbondanti, sono privi, a seconda dell’occorrenza e del tono, di pathos, di idillio, di accenti romantici, di slanci mistici, di capacità evocativa, di potenza drammatica; non muovono né commuovono, piatta prosa debolmente scandita da pallidi accenti, troppo spesso densa di contenuti banali, quanto meno espressi in una forma ovvia, poveri d’immaginazione… Insomma la poeta avrebbe fatto meglio a non cimentarsi con l’ampio respiro, meglio a non tentare la forma classica (?) dell’ottava che, di canonico, ha solo una successione di gruppi di otto velleitari versi, mal cadenzati (dieci, undici e perfino dodici sillabe, come abbiamo visto) e privi di rime. Sappiamo bene che non è la forma scelta e nemmeno il genere a premiare la poesia, la quale non ha bisogno di artifici per fiorire: esigiamo semplicemente che non si attribuisca alle opere quello che le opere non hanno. La Giovanna d’Arco della Spaziani non è scritta in ottave classiche, non in soli endecasillabi, non in fluente metrica, e non è nemmeno grande opera di poesia, non solo in quanto genere, ma pure in quanto “momento in cui si realizzano individualmente e si rendono intelligibili le possibilità creatrici e suggestive delle intuizioni e della fantasia”, come recita il Devoto. Per di più, essendo ritenuta il capolavoro della poeta, condannano la qualità artistica della medesima all’assoluta mediocrità.
Né salvano l’opera altri pregi che con l’arte di un poeta hanno poco a che vedere: la sostanza della poesia non è certo nelle indagini storiche, nei tratti più o meno fedeli alla realtà che la caratterizzano, non certo nei sopralluoghi, nel fascino esercitato sullo scrittore da uno specifico argomento o da un particolare personaggio. Sicché la valutazione della qualità poetica della Giovanna d’Arco della Spaziani deve prescindere da qualunque apprezzamento per le «zone non note o respinte dalla storiografia ufficiale» [6] esplorate e da simili peculiarità, e considerare purtroppo il poemetto, o romanzo popolare che dir si voglia, della Volpe un prodotto inferiore, e non poco, alle pretese dei vari Raffo e Vidiri Varano e di quanti vedono “la vate” torinese come una delle voci più alte del panorama letterario del Novecento.
[1] Brunetta Gian Piero, Guida alla storia del cinema italiano, Torino, Einaudi (2003), cap. IV, 6.
[2] Preferisco l’accento alla latina.
[3] Mythos.
[4] Non posso esprimere un parere personale, non avendo mai avuto né voglia, né occasione di leggere il romanzo (?…).
[5] Tale per aver saputo trovare scaltramente la via del successo?
[6] Così recita il risvolto anteriore del volumetto pubblicato dalla Marsilio nel dicembre del 2000.
___________________________
CONFRONTO FRA LA SCHIETTA OTTAVA CLASSICA
E LE PRESUNTE TALI DELLA SPAZIANI
_ _ _ _ _
D’un bel pallore ha il bianco volto asperso,
come a’ gigli sarian miste viole,
e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
sembra per la pietate il cielo e ‘l sole;
e la man nuda e fredda alzando verso
il cavaliero in vece di parole
gli dà pegno di pace. In questa forma
passa la bella donna, e par che dorma.
Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, XII, 69
Mentre aspetto vi dico della casa
rustica, dall’unico spiovente. [1]
In sei ci abitavamo, tutte insieme
dormendo, le tre femmine, in cucina.
In camera ci stavano gli uomini, [2]
mio padre Jacques insieme ai miei fratelli.
Alle cinque d’estate e d’inverno [3]
Puntuali ci svegliavano le pecore. [4]
Maria Luisa Spaziani, Giovanna D’Arco, I,2
Non si destò fin che garrir gli augelli
non sentí lieti e salutar gli albori,
e mormorar il fiume e gli arboscelli,
e con l’onda scherzar l’aura e co i fiori.
Apre i languidi lumi e guarda quelli
alberghi solitari de’ pastori,
e parle voce udir tra l’acqua e i rami
ch’a i sospiri ed al pianto la richiami.
Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, VII, 5
Ci fu una pausa in terra e in cielo, quasi
che il tempo si fermasse. Accanto al tronco
lentamente dall’ombra si annunziarono
l’aureola e il piumaggio di Michele.
In silenzio agitava le labbra. [3]
Io capii bene. Carlo non sentiva
né vedeva, se non una gran luce
che misteriosa tutta mi avvolgeva.
Maria Luisa Spaziani, Giovanna D’Arco, I,28
Fugge tra selve spaventose e scure,
per lochi inabitati, ermi e selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,
fatto le avea con subite paure
trovar di qua di là strani viaggi;
ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver sempre alle spalle.
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XXXIII,1
Ci accolse l’arcivescovo. Suonavano
a distesa trecento campane. [4]
Ancora folla immensa, contadini
e signori mischiati, come un giorno
accadrà nella valle di Giòsafat. [5]
Poco dopo arrivava il gran corteo
di Carlo da Chinon. Quando mi vide
scese dal suo cavallo e mi abbracciò.
Maria Luisa Spaziani, Giovanna D’Arco, IV,2
Tre volte e quattro e sei lesse lo scritto
quello infelice, e pur cercando invano
che non vi fosse quel che v’era scritto;
e sempre lo vedea più chiaro e piano:
ed ogni volta in mezzo il petto afflitto
stringersi il cor sentia con fredda mano.
Rimase al fin con gli occhi e con la mente
fissi nel sasso, al sasso indifferente.
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XXIII,111
Mi strinsero, baciarono le mani
piangendo a calde lacrime. Al cavallo
strappavano dei peli della coda,
prematura reliquia. Rideva [6]
felice Gilles de Rais, ed a fatica
raggiungere potemmo per la cena
l’ospitale palazzo dell’amico
tesoriere del duca d’Orleans.
Maria Luisa Spaziani, Giovanna D’Arco, III,12
Gli esempi citati del Tasso e dell’Ariosto evidenziano l’abisso di competenza metrica, di sensibilità musicale [7], di pensiero fra i due, questi sì, grandi poeti, e la sbiadita scrittrice della Giovanna d’Arco. Sarebbero comunque stati sufficienti anche artisti del calibro di Pulci, Boiardo, Pucci, Boccaccio, o addirittura saggi di qualche sconosciuto (non per demeriti) contemporaneo, dal talento ben più evidente. Come di seguito si evince.
Era sera per noi, ma sera scura:
la sera tutta ardea qual solfarino,
e su entrambi incombeva la ventura
d’andare arrosto senza rosmarino.
Ma il prode Olimpio, eroe senza paura,
non restò ad imprecare al reo destino;
lasciò il tinello e disparì nel retro,
ed io per non sbagliar gli tenni dietro.
Stefano Tonietto, Olimpio da Vetrego, Poema comicavalleresco II,2 (2010)
«Già mi sgorga di rime una fontana,
già mi s’intreccian sillabe ed accenti;
Olimpio, va’! Per la fede cristiana
combatti e vinci, e se non vinci, astienti.
L’impresa tua comunque sovrumana
propagherò, te spento, ai quattro venti».
Egli una mano volse in giù spedito,
drizzando il quinto ed il secondo dito.
Stefano Tonietto, Olimpio da Vetrego, Poema comicavalleresco XXXI,51 (2010)
http://www.odanteobenigni.it/2013/11/08/poesia-fra-quanto-e-quale-poco-o-niente-vale/
La stupidità umana
Chi per la Rete salpi, col favore
del vento nelle vele, e chi capace
regga il timone per il vario umore
dell’onda, scoprirà quanto loquace
forma di umanità lungo il fervore
dei porti si riveli e quanto spiace:
troverà l’esperienza che conferma
l’uomo carente e la natura inferma.
Conoscerà cervelli omologati
come da una catena di montaggio,
senza grigio che splenda e senza strati,
e lo sguardo che vede col bendaggio.
E leggerà gli scritti ineducati
sia per oscenità che per lignaggio,
e presunzione sempre, che non cura
quanto sia guasto il grano e la cottura.
Amato Maria Bernabei, L’infinito piatto, La stupidità umana 1-2
http://www.odanteobenigni.it/linfinito-piatto/
_________________
[1] Orecchio grossolano? Il verso è un decasillabo con accenti non canonici (1-5-9 anziché 3-6-9).
[2] Decasillabo, essendo uomini parola sdrucciola (salvo brutta dialefe gli/uo).
[3] Decasillabo, salvo brutta dialefe estate/e.
[4] Dodecasillabo sdrucciolo, salvo sineresi “tua”, nella parola pun-tu-a-li.
[5] Necessaria la dialefe in silenzio / agitava per avere un altro degl’innumerevoli brutti endecasillabi di questo poemetto.
[6] Altro clamoroso svarione musicale: il verso è un decasillabo con accenti canonici.
[7] Ancora un decasillabo canonico, per quanto sdrucciolo. Altro che i “fluenti endecasillabi sciolti (con qualche rallentamento di ritmo per sottolineare col decasillabo dei particolari momenti poetici)” di cui scrive Carla Vidiri Varano!
(http://www.ischialarassegna.com/rassegna/Rassegna1991/rass08-991/rass-libri.pdf) Che istanza poetica possono avere quelli più su riportati? La solita abitudine di voler giustificare l’ingiustificabile con arzigogolate trovate critiche (in questo caso proprio una generica baggianata che riverbera acriticamente le poco probanti ragioni addotte dalla stessa Spaziani nella Postfazione del suo libercolo). La verità è che ci troviamo di fronte ad una prosa ritmica, brutta come prosa e brutta come ritmo. Basta scrivere di seguito gli “endecasillabi” e nessuno si accorge più dei versi, ma nemmeno rintraccia la buona prosa: Ci accolse l’arcivescovo. Suonavano a distesa trecento campane. Ancora folla immensa, contadini e signori mischiati, come un giorno accadrà nella valle di Giòsafat. Poco dopo arrivava il gran corteo di Carlo da Chinon. Quando mi vide scese dal suo cavallo e mi abbracciò. Evidentemente è questo lo stile dei “grandi poeti contemporanei”, della cui rosa la Spaziani farebbe parte (sempre a detta della Vidiri Varano). Io però di grandi poeti non ne vedo da decenni nel panorama letterario italiano.
[8] Altro decasillabo canonico, non essendo indicata la dieresi sulla sillaba “quia”, che trasformerebbe il verso in endecasillabo.
[9] È ridicolo leggere del rimprovero (peraltro fondato) mosso dalla Spaziani a Franco Buffoni a proposito del libro Suora carmelitana: «Apriva a caso il libro, leggeva due versi e mi diceva: “Vedi, non cantano… questi versi non cantano”». Poi li confrontava con le “ottave” del poemetto Giovanna D’Arco, che leggeva per dare esempio di “canto”!… (http://www.nuoviargomenti.net/poesie/il-racconto-dello-sguardo-acceso/).
Abbiamo dimostrato però che la musicalità dei versi della “poeta” spesso manca e che, quando essa affiora, è quasi sempre fiacca e non esemplare. Basterebbe confrontare il suono che diffondono i distici finali delle ottave classiche citate con l’occasionale e sgradevole distico “spazianiano” La gloria della Francia e di Gesù. / Tutto ciò che lui disse un giorno fu (Canto I, ottava 14).
Solo i grandi hanno consapevolezze. I piccoli non altro che presunzione.
_____________________
Riprendiamo ora una delle ”ottave” della Spaziani:
Ci accolse l’arcivescovo. Suonavano
a distesa trecento campane. (decasillabo)
Ancora folla immensa, contadini
e signori mischiati, come un giorno
accadrà nella valle di Giòsafat. (decasillabo, per ultima parola sdrucciola)
Poco dopo arrivava il gran corteo
di Carlo da Chinon. Quando mi vide
scese dal suo cavallo e mi abbracciò.
Maria Luisa Spaziani, Giovanna D’Arco, IV,2
Proviamo a riproporla senza “andare a capo”:
Ci accolse l’arcivescovo. Suonavano a distesa trecento campane. Ancora folla immensa, contadini e signori mischiati, come un giorno accadrà nella valle di Giòsafat. Poco dopo arrivava il gran corteo di Carlo da Chinon. Quando mi vide scese dal suo cavallo e mi abbracciò.
PROSA, sciatta prosa impoetica, come già era negli artificiosi “a capo”! Non così se operiamo nello stesso modo con un’OTTAVA ariostesca:
Fugge tra selve spaventose e scure,
per lochi inabitati, ermi e selvaggi.
Il mover de le frondi e di verzure,
che di cerri sentia, d’olmi e di faggi,
fatto le avea con subite paure
trovar di qua di là strani viaggi;
ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle,
temea Rinaldo aver sempre alle spalle.
Ludovico Ariosto, Orlando furioso, XXXIII,1
Fugge tra selve spaventose e scure, per lochi inabitati, ermi e selvaggi. Il mover de le frondi e di verzure, che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, fatto le avea con subite paure trovar di qua di là strani viaggi; ch’ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, temea Rinaldo aver sempre alle spalle.
La versificazione e la musica sono intatte! La poesia è conservata, perché c’era e non poteva smarrirsi. Questa è arte!
Quindi bando alle esaltazioni gratuite, insussistenti, come quelle di Silvio Raffo che scrive: «La sua opera, di recente consacrata dal Meridiano Mondadori, è la prova più lampante della possibilità di coesistenza di registro alto e leggibilità, dunque di “tradizione” e comu-nicazione», dove per “registro alto” non si sa che cosa Raffo voglia intendere e dove si dimentica che già l’Ariosto aveva dato prova, ma prova schietta, insuperabile, della possibilità di convivenza di leggibilità ed altezza di poesia.
Cuce sempre veste goffa
chi non sa d’ago e di stoffa.
Amato Maria Bernabei
È forse il caso di abbandonare i preamboli e di accedere al cuore della questione.
Cominciando dal vanto che l’autrice fa della sua opera, accostandola spudoratamente, benché in modo in apparenza velato, ai capolavori dell’Ariosto e del Tasso, accanto a quello di riprendere un genere poco frequentato in Italia: «È un poema in ottave, genere popolare alle origini della nostra letteratura, tipico dei cantastorie, poi nobilitato dal Boccaccio prima d’imporsi come forma classica e illustre con l’Ariosto e il Tasso. È quindi in endecasillabi, sia pure senza la canonica rima finale […] Ed è soprattutto, con i suoi 1392 versi, un romanzo popolare, come dice il sottotitolo, genere raro in Italia e pressoché ignoto nel nostro secolo» [1].
In realtà, a mio modestissimo e forse irriverente parere, il risultato che l’opera della poeta torinese consegue non è romanzo, per l’impedimento della scelta metrica che produce (per imperizia?) una prosa elementare e sbiadita, né poema, per la versificazione piatta ed impotente, in cui la musicalità decantata dai più non è di sinfonia, di melodramma, di sequenza di lied o di ballate (molto più convincenti sono, per melodia e parole, i compo-nimenti di Fabrizio De Andrè) e non riesce ad avere nemmeno la leggerezza ritmata e la poesia dei testi espresse dai migliori cantautori.
La prima pagina dell’ibrido spazianiano (né romanzo, né poema, come abbiamo appena rilevato) già presenta più di qualche bruttissimo verso (in camera ci stavano gli uomini, che, fra l’altro, per essere endecasillabo sdrucciolo ha bisogno di una sgradevole dialefe: gli-uomini, essendo noto al lettore educato che il verso sdrucciolo è sempre un ipèrmetro e che di conseguenza la sillaba finale non va metricamente computata).
L’incipit è banale, e sembra difettare perfino di logica:
Vedevo un muro bianco. Voi direste
uno schermo […]
Noi non potremmo dire proprio niente, nulla potendo intuire di quello che viene introdotto… anche perché un muro non può richiamare in nessun caso uno schermo da proiezione per “una storia che si illumina”, ma al massimo uno schermo nell’accezione di riparo, o di barriera.
Da scolaretta maldestra, poi, la Spaziani avvia la sua sciatta “prosa versificata”.
Da tre anni aspettavo. Che cosa?
Mentre aspetto vi dico della casa…
Proprio scrittura degna di “una delle voci più autorevoli e suggestive della poesia contemporanea”!
A volte si ha proprio l’impressione che la critica, anziché muovere dal testo e dai contenuti di un’opera, parta dall’autore in quanto personaggio (divenuto tale per qualsivoglia ragione di carattere esterno al di lui valore) e dalla rilevanza delle sue vicende biografiche (nel caso della Spaziani soprattutto dal legame affettivo che l’astuta “volpe” strinse con Montale).
Dopo aver avvertito il lettore che
Alle cinque d’estate e d’inverno
puntuali ci svegliavano le pecore…
volendo forse suggerire che in primavera e in autunno si riuscisse a dormire di più… [2] la poeta s’incammina lungo 1392 noiosissimi versi, non senza qualche idea cervellotica, più adatta a un contesto da Mille e una notte, come l’incomprensibile e goffa lingua parlata dall’angelo, che rientrerebbe in un’esigenza teorico-estetica non nuova nella produzione della Spaziani:
Marò mivalla univallentes pria
cresciò bundantia crivellò carene,
multa de Dio convene arcisaviota
marlinevelle adasto. Lunsitoni,
gronsilampe sarrete ultravalente
microlombat antares unisarfiota [3]
crenalantoni crivellò carene,
unisarfiota ter unisarfiota.
Una lingua «composta da un miscuglio di suggestioni latine, greche, provenzali, francesi e tedesche. La lingua inesistente, inaudita, con cui la Spaziani fa parlare l’angelo non rappresenta un unicum nell’opera della poetessa torinese. Spesso torna, in diversi momenti e luoghi della sua produzione, il tema della lingua, del logos che si pone al di fuori di ogni interpretazione simbolica, della glossolalia o della voce pura [4]. L’angelo che porta questa voce è, per la Spaziani, la poesia stessa, ovvero quella forza che preme costantemente dai confini del territorio della lingua e del dicibile, deformando tali confini, facendo scorgere spiragli di enunciazioni inesplorate, zone di voce ancora pure»
(Riccardo Giacconi in http://helicotrema.blauerhase.com/maria-luisa-spaziani/).
Insomma, per tagliar corto: di classico la Giovanna d’Arco non ha proprio niente, se non il fatto che dal punto di vista della versificazione e della poesia (ma in larga parte anche della stessa scrittura) è un vero e proprio… classico bluff.
[1] Spaziani Maria Luisa, Giovanna d’Arco, Postfazione, Venezia, Marsilio 2000, pp.104-105. Con candida, ma inaccettabile ingenuità, purtroppo avallata dal relatore (relatrice) Prof.ssa Ricciarda Ricorda e dai correlatori Prof. Aldo Maria Costantini e Prof. Paolo Leoncini, la laureanda Giulia Dell’Anna scriveva nella sua Tesi di Laurea L’universo poetico di Maria Luisa Spaziani, discussa all’Università Ca’ Foscari di Venezia nell’Anno Accademico 2011-2012, «Se si dice che L’Orlando Furioso fu il poema della vita dell’Ariosto, sul quale pose mano fino alla morte, ebbene la Giovanna d’Arco è L’Orlando Furioso della Spaziani. Credo che il parallelo calzi a pennello, non solo per il continuo lavorio (che tuttavia per la Spaziani fu tutto un brulichio di idee che per anni rimasero chiuse nel profondo della mente) bensì anche per il metro dell’ottava».
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1601/819906-1165705.pdf;sequence=2
Con il “trascurabile” particolare che l’Orlando Furioso si compone di 38.736 versi, circa trenta volte il poemuccio della Spaziani, essendo poi, per grandezza poetica, sideralmente più in alto. Senza contare il fatto che quelle della Spaziani NON SONO OTTAVE (se non perché formate da otto righe) e tanto meno sono classiche.
[2] Per i meno avveduti precisiamo che l’osservazione è puramente ironica.
[3] Chissà quale giustificazione contestual-semantica ci darebbe la Spaziani per questo brutto dodecasillabo! Più facile dedurre che l’orecchio della sessantottenne signora abbia toppato.
[4] Evidentemente la Spaziani privilegia il livello fonico della scrittura poetica, pur non essendo capace di conseguire risultati di eccellenza sotto questo profilo. Del resto il livello semantico, povero delle caratteristiche che il linguaggio poetico esige, non è certo superiore. Poco si comprende la necessità della punteggiatura in un “testo” che sa di formula fiabesca.
_____________________
S C A R T I L E G I O
Una raccolta dei passi fonicamente e semanticamente più brutti
del brutto “ro-manzo popolare” della Spaziani
Vedevo un muro bianco: voi direste
uno schermo, una storia che s’illumina.
ottava 1
Da tre anni aspettavo: che cosa? (decasillabo canonico, o dialefe ni-a)
Mentre aspetto vi dico della casa
rustica, dall’unico spiovente. (decasillabo)
In sei ci abitavamo, tutte insieme
dormendo, le tre femmine, in cucina.
In camera ci stavano gli uomini, (decasillabo sdrucciolo, salvo sgradevole dialefe gli-uo)
mio padre Jacques insieme ai miei fratelli.
Alle cinque d’estate e d’inverno (decasillabo canonico, o altra dialefe, pessima, te-e)
puntuali ci svegliavano le pecore. (endecasillabo sdrucciolo, ma con sineresi tu-a)
ottave 1-2
Per caso da bambina avevo inteso
il parroco informarsi da mia madre
“se io sapessi”. Poi dimenticai,
ottava 4 p. 10
Mia madre la nutriva con la carne
di capra, a noi da sempre proibita (decasillabo, o dialefe pra-a)
tranne alle feste grandi e con decotti
ottava 5 p. 10
Non imparava a mungere le capre
rifiutava i lavori in cucina. (decasillabo, o dialefe ri-in, migliore di va-i)
ottava 6 p. 11
Anche il paggio era splendido. E portava
un misterioso rotolo pesante
che sciorinato risultò un tappeto.
ottava 7 p. 11
Secondo le istruzioni di quel paggio,
il tappeto fu issato accanto al letto
di Caterina ad attutire il gelo.
ottava 9 p. 12
__________________________
Le ottave 11 e 12 meritano una riflessione a parte.
Quella di far parlare l’Angelo con una lingua che sembra un grammelot teatrale usato per effetti comici o farseschi, appare una trovata di cattivo gusto, a prescindere dalle giustificazioni di carattere teorico, come quelle sostenute da Riccardo Giacconi (http://helicotrema.blauerhase.com/maria-luisa-spaziani/), per il quale «questa voce è, per la Spaziani, la poesia stessa, ovvero quella forza che preme costantemente dai confini del territorio della lingua e del dicibile, deformando tali confini, facendo scorgere spiragli di enunciazioni inesplorate, zone di voce ancora pure». Non c’è teoria che possa redimere un’invenzione più appropriata al mondo delle favole che ad un ambito epico che intende celebrare la figura e le gesta della “Pulcelle d’Orléans”, tanto più che la Spaziani non si dimostra in grado di reggere l’endecasillabo nemmeno in questa circostanza, inserendo, non si sa per quale recondito fine, un inspiegabile dodecasillabo, qual è il cervellotico verso microlombat antares unisarfiota, le cui sillabe di seguito vengono conteggiate:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mi cro lom bat an ta res u ni sar fio ta
Se le «zone di voce ancora pure» devono essere costituite da un’indecifrabile lallazione, non raramente sgradevole all’udito, anche a quello puramente interno e silenzioso, ben trionfi l’impurità vocale capace di far risuonare significati, più che novelli significanti (meno nobilmente balbettii) privi di convenzione semantica.
__________________________
Ripartiamo da un distico del tutto privo di buon gusto estetico:
La gloria della Francia e di Gesù.
Tutto ciò che lui disse un giorno fu.
ottava 14 p. 13
Finché un astuto a corte ricordò
la profezia di Merlino e disse:
«Un simbolo ci serve. Una bandiera
Basterà a rincuorare i Francesi. (necessaria almeno una brutta dialefe)
Portiamo Caterina (che comunque
è di sangue reale) fra i soldati.
Diamole un bel cavallo, suggeriamo
le frasi a effetto che dovrà gridare.
ottave 15-16
…Seguono scialbe (spesso sgraziate) ottave fino alla 27a, che conclude il primo canto.
Davvero siamo di fronte agli endecasillabi probabilmente più brutti della storia della letteratura italiana! Una versificazione da scolaretto apprendista in cattiva scuola!
Se l’endecasillabo doveva essere uno strumento per rendere ritmica una bella prosa “popolare”, il tentativo è mal riuscito, sia per quanto riguarda il modo di trattare il nobile verso che per una prosa non più tale, perché versificata (male) e decisamente brutta nel suo andamento e nei suoi contenuti. Quanto sostenuto risalta in modo evidente scrivendo di seguito, senza andare a capo, i versi del “romanzo” della Spaziani.
Per i canti successivi sarebbe interminabile e noioso continuare a riportare tutti i brutti passi: pertanto, ed eventualmente, ne sceglieremo in futuro alcuni particolarmente idonei ad arricchire lo “scartilegio” e ci dedicheremo se mai al bruttissimo Epilogo del “romanzo”.
In conclusione, fiacchissima opera di poesia (se tale possa essere considerata) la Giovanna d’Arco e, in ogni caso, modesto esempio di letteratura. Non si capisce come nessuno se ne sia accorto o abbia voluto accorgersene.
Probabilmente la migliore “ottorighe” (abbiamo già detto che quelle della poeta non sono ottave classiche) è quella riportata, forse non a caso, nella quarta di copertina, peraltro nemmeno adeguatamente riassuntiva, come avrebbe dovuto essere per la sua collocazione, dello scopo e dei contenuti del volumetto (tale perché piccolo e perché di poco valore).
Amato Maria Bernabei



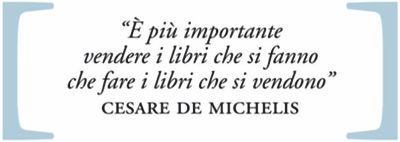
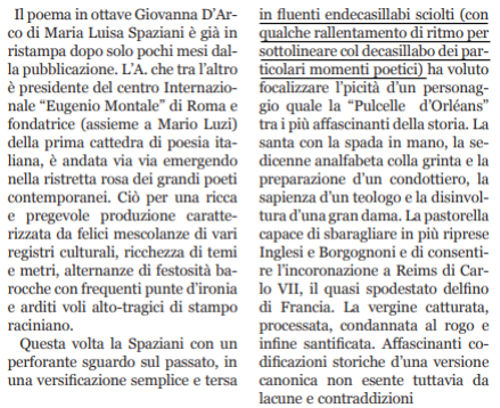
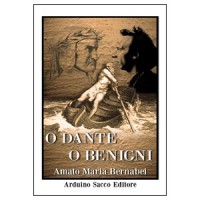
*

To prove that you're not a bot, enter this code