Non sono un filosofo, ma mi capita di pensare, non so quanto adeguatamente, non so quanto in pofondità… ritengo però sia sempre importante condividere i propri pensieri. Nessun seme non seminato sarà mai produttivo.
Lo zero è paragonato al nulla,
ma a seconda del posto che occupa
fa esplodere le cifre, o le umilia
(Armando Torno)
Così quel nulla che molti considerano la felicità…
- – - – - -
Troppo spesso la lingua lega concetti diversi, non solo nelle sfumature, a un medesimo termine. E quando la differenza semantica non si può connettere con precisione al contesto logico, la confusione è inevitabile, e può divenire tale da produrre fraintendimenti o travisamenti che pregiudicano la comprensione dell’oggetto, la messa a punto delle idee e la comunicazione delle medesime.
Evidente che il “bacino” del Mediterraneo non potrà mai essere un gesto affettuoso, come il “bacino” della buona notte non potrà confondersi con il cingolo osseo anatomico che costituisce la parte inferiore del tronco. Meno aperte si rivelano però le differenze quando sono in gioco parole che alludono propriamente a qualcosa, impropriamente ad altro, o vocaboli che contengono sfumature in apparenza prossime, in realtà, molto distanti. Nel secondo caso si pensi ad esempio ai lemmi “poesia”, “musica”, nel primo alla voce “felicità”.
Felicità, appunto, è termine che può dar luogo ad un equivoco rilevante: perché il suo senso peculiare dovrebbe essere quello di “compiuta (e aggiungerei duratura) esperienza di ogni appagamento”, come riporta il Devoto; mentre in modo non univoco il dizionario Treccani online recita: “stato e sentimento di chi è felice”, e il De Mauro ribadisce: “stato d’animo di chi è felice”, entrambi includendo, nella generica e perfino tautologica definizione, sia la condizione di perennità, che il vocabolo a mio avviso contiene, che la “disposizione d’animo” del transitorio, e neppure totale, appagamento, o quanto meno evitando di chiarire il senso della parte nominale del predicato “felice”, e dunque la sostanza della stessa felicità, e costringendo chi consulta ad ulteriore ricerca. Da cui deriveranno altre perplessità; perché a proposito dell’attributo felice il Treccani spiega: “Che si sente pienamente soddisfatto nei proprî desiderî, che ha lo spirito sereno, non turbato da dolori o preoccupazioni e gode di questo suo stato”… il quale se sia effimero o duraturo non si chiarisce, lasciando dubbiosi se tale aggettivo possa qualificarlo, o se il compilatore intenda riferirlo in modo inadatto a denominazioni di esperienze fuggevoli, come la gioia, la contentezza, o simili altre.
Per quanto detto, appare opinabile anche l’insieme delle voci segnalate nel dizionario dei sinonimi e dei contrari del Gabrielli (gioia, contentezza, benessere, esultanza, tripudio, giubilo…) che meglio si confarebbero ad altro segno linguistico. Perché chi è contento – valga come esempio – non è felice, e vive, in una condizione consueta di non felicità, una pausa di appagamento relativo.
Non che pretenda che un dizionario si trasformi in un trattato di filosofia, ma almeno che aderisca ai significati nel modo in cui l’umana esperienza e le conquiste del sapere, nel tempo, li hanno precisati.
Fu “il persuasore di morte” Egesia di Cirene, che nel IV secolo a. C., collegando ai piaceri l’umana felicità, in una visione edonistica, negò per primo la possibilità di conseguirla, ragionando sulla rarità e labilità di quelli.
Circa duemila anni più tardi, nei Nuovi saggi sull’intelletto umano, Gottfried Wilhelm Leibniz avrebbe scritto: “Io credo che la felicità sia un piacere durevole” (Nouveaux Essais, II, 21, 42), ribadendone in fondo l’inattingibilità.
Sarebbe stato però Immanuel Kant, nella Critica della Ragion pratica, a sostenere che “la felicità è la condizione di un essere razionale nel mondo al quale, nell’intero corso della sua vita, tutto avvenga secondo il suo desiderio e la sua volontà” (Dialettica, sez. 5), precisando nella Critica del Giudizio, al § 8, che quello di felicità è un concetto che l’uomo non deriva dall’istinto o dalla sua animalità, ma cui perviene in maniere diverse, spesso mutandolo e altrettanto spesso in modo arbitrario. Kant considera la felicità, insieme con la virtù, intesa come “conformità della volontà alla legge”, parte integrante del sommo bene, dunque non realizzabile nel mondo naturale (Critica della Ragion pura, Dottrina del metodo, II, sez. 2). Nicola Abbagnano riconosce al filosofo tedesco il merito di “aver enunciato in modo rigoroso la nozione di felicità” e quello di aver dimostrato “che tale nozione è empiricamente impossibile, cioè irrealizzabile”. Non è concepibile infatti, aggiunge Abbagnano, sempre riferendo il pensiero di Kant, “che siano soddisfatte tutte le tendenze, inclinazioni, volizioni dell’uomo perché da un lato la natura non si preoccupa di venire incontro all’uomo in vista di tale soddisfazione totale e dall’altro perché gli stessi bisogni e inclinazioni non rimangono mai fermi nella quiete dell’appagamento” (Critica del Giudizio, § 83). Con il suo rigore logico Kant rese praticamente inservibile la nozione di felicità, se non su un piano intelligibile, nel “regno della grazia”, come egli stesso ritiene (Critica della Ragion pura, al passo citato), o in ogni caso metafisico.
Per questo i filosofi successivi furono costretti a sviluppare la concezione in senso sociale (Hume, Bentham, i due Mill), accezione cui si rivolge la stessa Costituzione americana, che include “la ricerca della felicità” fra i diritti naturali e inalienabili. Alla tradizione anglosassone, che guarda alla felicità in termini di “piaceri socialmente partecipabili”, si rifà Bertrand Russel (La conquista della felicità, 1930), pervenendo a una formulazione basata “sull’eliminazione dell’egocentrismo e sull’apertura alla molteplicità degli interessi ed ai rapporti dell’uomo con le cose e con gli altri uomini” (Abbagnano), antitetica rispetto all’autosufficienza del saggio vagheggiata dagli antichi filosofi (Aristotele, Etica Nicomachea, X, 7, 1177 a 25).
In tempi recenti il rinato interesse per il concetto di felicità vede divisi i pensatori fra quanti ne precisano un “significato debole” (appagamento parziale di istanze umane ritenute di volta in volta centrali o imprescindibili), e coloro che propendono per un significato forte, coltivando l’esigenza dell’appagamento totale e ritornando così ad un’aspirazione metafisico-religiosa di tipo tomistico (Summa Theol., I-II, q. 2, a. 8), o pervenendo al pessimismo di Camus, che riprende a considerare l’impossibilità dell’appagamento per l’urto con “il silenzio irragionevole del mondo”, o dovendo infine ammettere nell’uomo una tensione verso la pienezza che deve però ripiegare, nell’assenza di un referente oggettivo, su una nozione relativa di felicità, la sola sperimentabile.
Si vede allora come, in termini lessicali, sia opportuno separare almeno due piani distinti sui quali si è articolato il pensiero umano e riservare al termine felicità il senso di uno stato onnicomprensivo e perenne di soddisfazione piena – miraggio, purtroppo, della vita reale, lecita aspirazione in una dimensione trascendente – e ricorrere a tutta la gamma dei sinonimi plausibili per riferirsi, di volta in volta, a sentimenti compatibili con la vita dell’uomo sulla terra: la contentezza, la gioia, la letizia, la serenità, la soddisfazione, l’allegria, l’esultanza, o qualunque altra soddisfatta, ma pur sempre instabile, condizione dell’animo.
Nel volume I miti del nostro tempo, Umberto Galimberti propone un’interessante lettura del concetto di felicità, con l’intenzione di smitizzarne l’idea di inaccessibilità e di consegnare all’uomo la formula idonea per viverla, sia pure in termini che la riducono a semplice capacità di serena accettazione dei limiti imposti dalla natura, di realizzazione della propria forza vitale nel modo migliore possibile. Nella trattazione sembrano però sovrapporsi ambiguamente le numerose accezioni che alla parola felicità vengono impropriamente imposte.
Divergendo dalla visione del Galimberti, io rivendico per l’uomo il diritto al sogno, che ha valore terapeutico non solo come attività psichica negli eccentrici orditi del riposo, ma anche nello stato di veglia, come obiettivo improbabile – creduto, però, e perseguito -, di progetti esistenziali. Rivendico perciò il senso di una felicità assoluta da rincorrere con il desiderio anche oltre gli angusti termini della vita, con la consapevolezza che una meta così ambiziosa comunque non preclude, nel corso dell’esistenza, il godimento di soddisfazioni e gioie temporanee alternate alle ineludibili vicende del dolore.
Concepire una “felicità su misura” è l’ingannevole prospettiva del voler considerare soddisfacente pienezza la continenza, ovvero la contentezza, artificioso, perché caduco, sentimento di felicità imperfetta, riconducibile a quel modello, pur esso irrealizzabile, che vagheggia l’uomo saggio e per saggezza concepisce un equilibrio “contro natura” che si appaga del possibile, condannando ancora una volta alla caduta il volo di Icaro, all’annegamento l’insopprimibile desiderio di conoscenza di Ulisse. Sono queste “follie”, invece, che innalzano gli umani edifici. Chi voglia illudersi pensando che la “misura” dia quiete all’uomo, forse non considera che la quiete stessa è una forma di morte ante mortem. L’uomo vive nel tendere, vive della sua inquietudine, conosce dall’inquietudine, nell’inquietudine trova senso. Come potrà mai essere “felice” una felicità paludosa in cui ciascuno sia chiamato a “governare se stesso per la propria buona riuscita” (Galimberti), in cui l’uomo sia la misura di sé? E quale sarà mai il parametro di valutazione della buona riuscita, senza presupporre l’impossibile possibilità di conoscere a-priori, ciascuno, le proprie risorse?
L’uomo nutre aspirazioni che sopravanzano i limiti del possibile, troppe da poter essere ignorate. E se appare irragionevole che nel vagheggiamento egli dilati l’ambito della propria esperienza e concepisca realtà che la oltrepassano, e verso di loro si protenda, non si stima (e si dovrebbe) tale propensione come probabile indizio di una sfera che ci pertiene, ma che sfugge alla piena manifestazione e tanto più al controllo. Ciò che è, non può non essere, e l’uomo è anche codesto suo apparente trascendere se stesso. Non si nega quanto nella sua essenza non è conosciuto solo perché non è conosciuto, né ci sono ragioni valide per smentire il pensabile, che evidentemente trova spunti e sorgente nel sensibile, benché non di rado lo travalichi.
Se accade che un’incompiutezza si riconosca ed avverta la spinta al completamento, che il limitato si affacci oltre il confine, sull’immenso, ¿dobbiamo dedurne che si tratti di un’ “impertinente” (irriverente e non pertinente, insieme) violazione che il finito porta alla sua natura, o che sia nella natura del finito sapersi e orientarsi al compimento nel falso opposto che lo contiene? L’infinito non può essere infatti il contrario del finito, altrimenti sarebbe a questo antitetico, e dunque esterno, e alla sua infinitezza mancherebbe ogni singola finitezza, al punto da doverlo concepire “vuoto”…
Il finito non può che essere una componente del tutto, in cui continuamente tende a risolversi.
Talché nell’infinitezza l’uomo può concepire una felicità senza limiti, e ad essa aspirare.
Amato Maria Bernabei

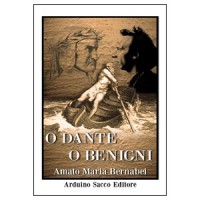
*

To prove that you're not a bot, enter this code